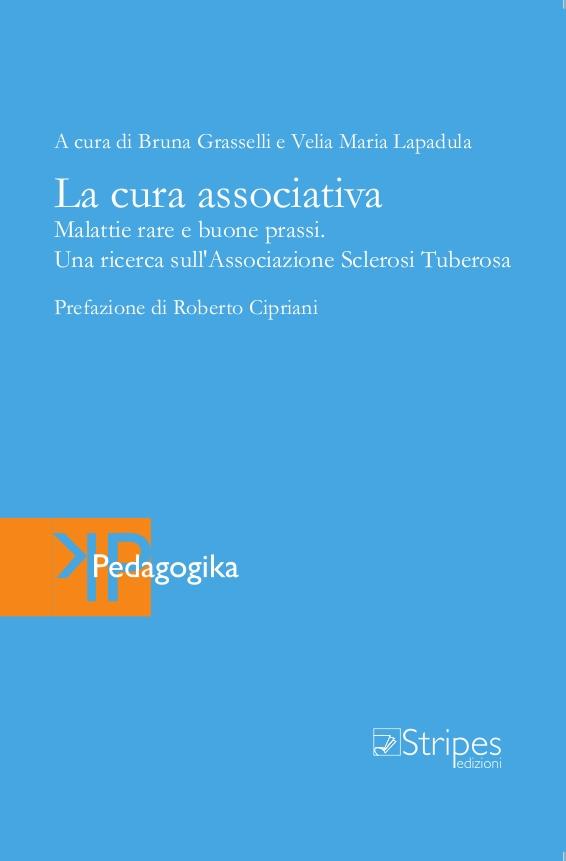Bimbi e città
Il premio Nobel Josè Saramago ha recentemente scritto un saggio titolato “Il mito della caverna”. In tale saggio si ripropone, aggiornandolo, il mito esposto da Platone nel VII libro della Repubblica, secondo il quale la condizione degli uomini nel mondo è quella di schiavi dentro ad una caverna, che conoscono il mondo attraverso le ombre delle cose esterne proiettate sul muro della caverna. Non conoscono e non vedono le cose e le persone reali, conoscono solo le immagini d’ombra che la luce esterna getta sullo sfondo. Lo scrittore portoghese sostiene che anche l’uomo moderno, alle soglie del 2000, vive nella stessa condizione dell’uomo della caverna platonica.
L’uomo moderno infatti si limita a conoscere il mondo attraverso uno schermo catodico che riproduce immagini che rappresentano la realtà, è insomma prigioniero di uno schermo mediatico che filtra il mondo e che fa vedere unicamente un’ombra della realtà. E’ la riproposizione della tesi che L’uomo e il bambino di oggi sono prigionieri di una conoscenza teleguidata e non partecipata. E’ la convinzione che, nella società dell’informazione e dell’informatica, ai bambini siano negati approcci diretti alla vita reale e che i loro processi di apprendimento siano costruiti su immagini, fatti e voci appartenenti ad un mondo virtuale che è solo la rappresentazione simulata della realtà. Questa opinione, suggestiva e inquietante, è sicuramente degna di ascolto e di riflessione; ma nella sua versione assoluta e radicale, è di certo confutabile. Ed una risoluta e pronta confutazione di questa tesi neoplatonica ci arriva dalla lettura di Reggio tutta. In questo libro infatti i bambini dimostrano di possedere una conoscenza della città sicuramente “non derivata” da approcci virtuali o da mediazioni catodiche. Le parole, le idee e le interpretazioni proposte dai bambini in queste pagine testimoniano, in modo evidente, quanto la città sia conosciuta, da loro, attraverso L’interazione con la propria esperienza di vita e attraverso soprattutto il filtro elaborativo dei propri racconti biografici. La città di cui parlano i bambini non è tanto quella dei serial televisivi o quella della iconografia classica delle megalopoli moderne, ma è piuttosto la città dove abitano e dove vivono, che conoscono e descrivono per averla frequentata e praticata. Infatti nei racconti e nei disegni dei bambini la fisicità e la sensorialità della città non sono scomparse né sono messe in secondo piano, esse appaiono ben percepite e rappresentate e sono anzi fonte generativa di originali e personali percorsi rielaborativi, dove il materiale e L’immateriale dialogano insieme, ai confini tra realtà e immaginazione. Del resto nelle parole dei bambini la componente fisica della città (palazzi, mattoni, muri… ) non è poi così prevalente come potrebbe sembrare. Credo che in Reggio tutta esca visibilmente anche una “città invisibile” fatta di storia, di valori condivisi, di istituzioni sociali, di stili di vita e di tante altre componenti intangibili che testimoniano come i bambini ben avvertono la presenza di una “realtà urbana incorporea” che sfugge agli occhi ma non all’intelligenza e al cuore, appunto perché rappresenta L’anima autentica della città, ovvero la sua identità più profonda. E’ innegabile tra L’altro che l’identità autentica di una città sia difficilmente afferrabile nelle cosiddette guide turistiche e negli atlanti geografici, efficaci spesso nel fotografare la realtà ma incapaci, quasi sempre, di rappresentarne lo spirito vitale. E’ per questa ragione che ognuno di noi conosce ed apprezza molte città non tanto per averle visitate ma per averle piuttosto incontrate nei romanzi, nelle poesie o nei film. La Parigi di Balzac o di Proust, la Londra di Dickens e la Dublino di Joyce restano di certo tracciate nella mente di tanti lettori come città-emblema di un’epoca o di un sentimento o di una società. La stessa Manhattan (New York), spesso assunta come immagine simbolo della metropoli contemporanea, ha saputo sfuggire a questo stereotipo iconografico grazie soprattutto ai film di Woody Allen che ce l’hanno fatta riscoprire sotto una diversa luce e una diversa forma. Insomma sembra che le città, per essere comprese ed apprezzate, non debbano essere descritte ma raccontate. Anche Reggio tutta non sfugge a questa regola: una sua virtù è che, dai bambini, la città non viene solo descritta nei suoi particolari, ma piuttosto raccontata per il suo carattere e per la sua natura. La stessa generosità elencativa di luoghi, di spazi e di itinerari, che certo colpisce a tratti il lettore
attento, non è tanto il prodotto di una bulimia espositiva o di un’ossessione per il dettaglio e il frammento ma piuttosto la dimostrazione di come i bambini avvertano, forse in modo rarefatto e sfumato, la ricchezza e la complessità della città. Al bambino dei cento linguaggi corrisponde insomma una città dai mille volti e dalle tante anime. Non è pertanto una visione parcellizzata e frantumata quella che si percepisce dall’enumerazione meticolosa dei luoghi e dei palazzi, non è una “città a spizzichi” quella che, a mio avviso, è raccontata dai bambini. C’è piuttosto in loro il tentativo di sfuggire all’immagine “unidimensionale” della città evidenziandone il suo policentrismo, la sua eterogeneità e la sua identità plurima, anche a costo, a volte, di irrobustire le argomentazioni e le esposizioni con richiami fantastici a luoghi immaginari. Anche in Reggio tutta ci vengono presentati dai bambini, qua e là, luoghi reali, modificati dalla forza creatrice dell’immaginazione. Si deve però prendere atto che comunque il quadro complessivo che ne esce non ne risulta falsato bensì arricchito. Infatti di solito lo sguardo interpretativo di chi la città non la frequenta come turista ma come abitante, costruisce fondali di riferimento che, anche se non basati sull’esattezza descrittiva, risultano saldamente ancorati all”‘autenticità dei vissuti e alla sincerità delle cose sentite. A questo proposito serve ricordare che molte guide turistiche di Londra indicano in Baker Street 201 L’esatta ubicazione della casa di Sherlock Holmes che, ovviamente, non è mai esistita se non nelle pagine dei racconti di Conan Doyle. Questo a dimostrazione di come ogni città costruisce la propria storia biografica attraverso riferimenti a personaggi, fatti e luoghi, reali e irreali, che spesso si intrecciano e si mescolano fino a fondersi in un tutto indistinto: questo è quello che avvertono anche i bambini, né più né meno. Un altro interessante aspetto che si evidenzia nella lettura di queste pagine è, se cosi si può dire, L’opzione costruttivista che i bambini sembrano compiere rispetto alla genesi e alla crescita della città. La città è costruita dagli uomini: questa sembra essere una assunzione indiscutibile per i bambini. Anche se poi le loro parole tendono a voler precisare che la città nasce e cresce rispondendo ai bisogni della gente (incontrarsi, divertirsi, lavorare, studiare …) e quasi affidandosi ad una propria forza autogenerativa e autorganizzativa. E? come se i bambini fossero convinti che negli anni e nei secoli la città abbia sviluppato la capacità di adattarsi quasi spontaneamente alla vita e alle attese di chi la abita. Se questa percezione ha un fondamento, ne risulterebbe una asserzione teorica di grande attualità, sulla quale stanno interrogandosi in questi ultimi anni tanti studiosi ed intellettuali: “La città è pianificabile a tavolino attraverso le regole e gli ordini degli urbanisti e degli amministratori? Il costruttivista classico risponderebbe positivamente in quanto ritiene che tutte le istituzioni sociali e/o culturali (lo Stato, il diritto, L’economia, la scuola, il linguaggio, la città … ) siano nella loro genesi e nei loro mutamenti frutto di piani intenzionali e di scelte deliberate e consapevoli. Egli solitamente pensa che costruire, in ambito sociale, significhi attenersi al rispetto dei progetti pianificati, così come in altri ambiti (edilizia, meccanica) ci si attiene al rispetto delle leggi della fisica e della tecnica. Molti però oggi pensano che la maggior parte di ciò che esiste in società e di ciò che l’umanità ha realizzato nel corso dei secoli sia il risultato non programmato e non previsto delle interazioni tra gli individui. Insomma, sempre più persone ritengono che, sebbene le “creazioni sociali” (e le città sicuramente lo sono) siano il frutto dell’azione umana, poche di esse sono esiti di umani progetti premeditati ed intenzionali. Come dice Popper “solo una minoranza delle istituzioni sociali sono volutamente progettate, mentre la gran maggioranza di esse sono venute su spontaneamente, cresciute come risultato imprevisto e non cercato di azioni umane”. L’esempio classico è rappresentato dal linguaggio, la creazione sociale più diffusa ed utilizzata. Come si sa il linguaggio non è stato inventato e progettato da nessuno; la sua genesi non la si può trovare in un esplicito e programmato piano di uomini che, riunitisi in gruppo, si siano accordati per costruire il linguaggio. E’ così anche per la città? Gli studi dei sociologo Raymond Boudon sugli effetti perversi e indesiderati di qualsiasi azione intenzionale e sull’imprevedibilità sociale ed epistemologica dell’agire umano lasciano credere che questa regola valga anche per la città, la cui nascita e il cui sviluppo spesso si realizzano al di là e al di fuori di ogni tentativo di predeterminazione fatta a tavolino, soprattutto se questi tentativi sono pensati e praticati come atti di imperio voluti dall’alto. Certo questi appaiono interrogativi ed argomentazioni lontani dai pensieri e dalle conversazioni dei bambini sulla città e in specifico su Reggio Emilia, ma si può ritenere che anche i bambini siano attraversati dal desiderio di poter soppesare e discutere idee e domande di questo tipo. Tra loro infatti c’è chi sostiene che la struttura della città (piazze, portici, centro… ) possa favorire – o inibire – alcune pratiche sociali, quasi pensando che la tipologia urbana possa influenzare la socialità e le relazioni civili, e modificare il modo stesso delle persone di percepire i rapporti con i propri vicini di casa o i propri amici. Fatte le dovute proporzioni, questi sembrano essere i teorici della “città che produce coesione sociale”. Altri invece sembrano propendere per L’idea che siano le abitudini e gli usi degli abitanti a connotare in un senso o in un altro gli spazi e le strutture della città, a volte riuscendo a dare vita e vitalità anche agli oggetti e agli ambienti più insignificanti. Questi bambini sembrano dirci, parafrasando una nota poesia di A. Machado: “Cittadino, non c’è la città, sei tu che fai la città”. Insomma, la lettura di questo libro ha il potere di tradire molte delle attese di noi adulti. A questo proposito vorrei riportare due esempi di “attese tradite”. Primo esempio: noi adulti constatiamo quotidianamente, nei Balcani, in Africa e in tante altre parti dei mondo, che delineare confini è diventato sinonimo di massacri e di violenza; in fin dei conti è come se il mondo ci dicesse: il confine è sangue. Per fortuna i bambini, utopici abitatori di futuro, ci stupiscono e ci ricordano che il confine è fumo. Secondo esempio: molti di noi iniziano la lettura dei libro convinti che nel rapporto con la città i bambini non possano che segnalarci preoccupazioni forti per lo stato di ?degrado? della vivibilità urbana (traffico, inquinamento, assenza di verde…). Ed invece anziché bambini impensieriti e pensierosi si incontrano bambini pensatori che ci suggeriscono anche di riflettere sul dilemma, antico e moderno: è la città che dà forma alla gente, o è la gente che dà forma alla città?