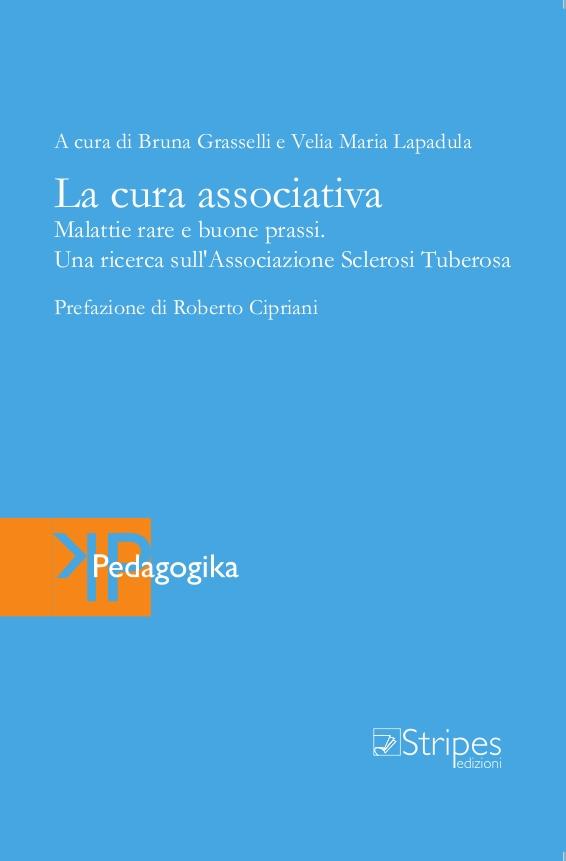Paradossi della libertà
La libertà è¨ taglio, rottura, anche distruttiva e violenta”
Libertà: non c’è parola più abusata e, nel contempo, più necessaria a cui l’essere umano ricorra. A proposito o a sproposito: chi del resto può dirlo tanto facilmente? La libertà è un’anguilla che sguscia di mano a chi la ricerca o a chi ambirebbe dominarla. Più ineffabile dell’amore, della verità del sapere o di chissà cos’altro, la libertà confina nel suo intimo con un indefinibile che, non per questo, manca di associarsi a un irrinunciabile. Proviamo sinteticamente a dirne qualcosa.
La libertà e l’impossibile
I muri delle nostre città sono i fogli su cui si depositano messaggi altrimenti indicibili, forse. Sono segni, slogan, gli appelli che si offrono allo sguardo anonimo del passante. Si indirizzano a tutti e a nessuno in particolare. Talvolta sono firme, camuffate o dissimulate in un nome d’occasione. Tracce, impronte, attraverso cui chi le lascia segnala una presenza, cerca di marchiare, in maniera più o meno incancellabile, un territorio. Si direbbe che, quantomeno, voglia far proprio o voglia trovare un posto in cui poter iscrivere la propria individualità, qualcosa di suo senza sentirsi oppresso dagli altri. Un sasso scagliato in uno stagno o contro una vetrata. Non sono discorsi, né prese di posizione. Probabilmente, a loro modo, invocazioni. Che importa? La libertà, in fondo, è anche questo. E’ la porta che si sbatte, magari con violenza, meglio, tanto meglio se in faccia a qualcuno. Il grido, l’urlo.
Nel suo fondo più intransigente, la libertà si coniuga con una negazione che l’alfa privativo del greco ben traduce (la “a” che compare all’inizio di molti parole, quali amorale, asettico, asessuato…), specie se rappresentata all’interno di un cerchio, come nel logo dell’anarchia. Si dica quel che si vuole, ma l’essenziale sta lì. La libertà è taglio, rottura, anche distruttiva e violenta.
La libertà si associa all’immagine del nomadismo. Espressione di un’ irrequietezza indomabile, eterna apologia dell’andarsene. Fisicamente o mentalmente. L’importante non è arrivare, non è fermarsi. Il viaggio è il fine. Non ha meta. Via, via, via da qui.
Il vento che, come da copione, soffia sul fuoco della libertà sposa ora cause nobili e sacrosante; ora insopportabilità isteriche; ora, ancora, nasconde le seconde nelle prime o viceversa. Nell’epoca moderna, le forme popolari dell’arte hanno fornito il loro decisivo contributo nell’alimentare una simile tensione, nel rinforzarne l’immaginario. Pensiamo, in particolare, a due di esse.
La prima è il romanzo. E’ il modello letterario che, nella sua sensibilità, anticipa i tempi che verranno, rompendo con l’epica e la sua retorica. In essa il suo oggetto era il passato, la tradizione la sua fonte. Esisteva una distanza invalicabile tra quel mondo, chiuso e gerarchicamente determinato a cui il testo si riferiva, e l’attualità di chi scriveva o leggeva. Il romanzo, invece, riunisce quello che l’epica differenziava. Abolisce la distanza. Si occupa del presente. Smaschera l’ipocrisia della retorica, evidenzia l’insensatezza di convenzioni e costrizioni, mette in risalto la forza trascinante delle passioni, quelle che, insomma, non si lasciano imbrigliare da una ragione che, nello scontro con le stesse, palesa la sua ristrettezza, la sua aridità. Il romanzo non teorizza, descrive. E’ irruente democrazia all’opera.
La seconda forma artistica che determina e accompagna il presente è la canzone, quella che nasce nel secondo dopoguerra. Più ancora del romanzo, essa punta al cuore dell’emozione. Ancor più direttamente. Scavalca, non di rado, la parola. Sino a giungere alla realtà più profonda del soggetto: il corpo. L’emozione incontra allora la sensazione, fatica a distinguersi: move your body. La sollecitazione alla libertà non potrebbe reperire una voce più prossima e sensibile. Mito dionisiaco che si rinnova, quasi inavvertitamente, quasi banalmente. Un romanzo lo si cerca, richiede un’attenzione nella lettura, la canzone passa dovunque. E’ dappertutto. L’acqua sporca della musica, la chiama Kundera. I giovani neri affrontavano la polizia razzista sudafricana sulle note di un celebre ritornello di The wall dei Pink Floyd (“We don’t need no education, we don’t need tought control…”). Ma Roger Waters ha più volte sostenuto come ci sia qualcosa di fascista nel rock. Il film d’animazione tratto dall’opera musicale del complesso inglese lo sottolinea creativamente. Lester Bangs, il più originale e celebre critico rock che la storia della musica pop ci ha consegnato, parlava spesso di “fascismo edonista” e “divertimento forzoso”.
Ecco, dunque, l’equivoco insolubile, l’intreccio indistricabile che nessun manicheismo può pensare di risolvere a priori, una volta per tutte. Paradossi della libertà, malintesi a cui può spesso piegarsi una domanda, al fondo, nella sua sostanza incontenibile.
D’altronde, guardando retrospettivamente, non è l’illuminismo che ha forgiato la scena contemporanea. Il romanticismo ha avuto storicamente bisogno dell’illuminismo per togliere definitivamente il bavaglio che la soggezione all’autorità imponeva al discorso sociale ed alle esigenze individuali. Ma è poi il romanticismo a fare da battistrada al moderno. Nell’impatto con il mondo, che quest’ultimo ha contribuito a creare, il romanticismo prende le vesti del realismo più spinto. Non quello degli oggetti e delle cose, ma quello dei sentimenti, della immediatezza pulsionale, della diffidenza verso astrattezze troppo lontane. O, comunque, sentite come tali.
Al cuore non si comanda. Figuriamoci al corpo. L’orologio della storia, una volta caricato, non torna più indietro. La libertà, per come lo spirito romantico la sospinge e la legittima, non può non rispecchiarsi nella cultura che la canta, che la esalta. A ragione, ma anche a torto. La miniera cui attingere è, comunque, quella. Il filone, la vena sono inesauribili. Ci si aggrappano il padrone e le folle, il poeta e chi cerca disperatamente di sopravvivere. Chi cerca di dominare e di opprimere, chi ne contrasta il dominio. Libertà, sempre libertà, sempre in suo nome.
La parola e l’istituzione
Laddove, tuttavia, il richiamo romantico è destinato ad articolarsi in una dimensione meno ineffabile, meno aperta ad ogni possibile avventura è esattamente nel punto in cui è confrontato con il suo rovescio, quello cioè costituito dall’istituzione. Se la libertà è negazione, l’istituzione è, hegelianamente, negazione della negazione. L’unica istituzione libera è quella che non c’è, quella di cui si vagheggia sui muri. Utopicamente.
Istituzione è una parola meno impegnativa di libertà. Finanche, ovviamente, meno estesa e suggestiva. Semplificando possiamo supporre due tipi fondamentali di istituzioni. Il primo è quello costituto dal linguaggio, l’istituzione per eccellenza. Trascendente, prima che storico, il linguaggio è ciò che determina l’umano, ciò che rende possibile l’accesso del singolo alla parola. E, dunque, a una sua strategia all’essere. Non lo si dimentichi, però: il linguaggio (e la sua implicita normatività) è un trauma che, nella sua assunzione, nessuno poi ricuce del tutto. Scelta sì, ma obbligata. Il suo inconscio rifiuto confina il soggetto al demone della follia. Nelle sue manifestazioni più gravi, all’impossibilità del costituirsi di un pensiero. Ecco la libertà più radicale.
Luca, un giovane psicotico, che balla in un luogo “protetto”. La musica a palla. Si agita anche con una certa destrezza. E’ libero. Potrebbe fare qualsiasi cosa, non ha freni. Non risponde alla parola, al dialogo. A quale prezzo?
Il secondo tipo di istituzione è declinabile al plurale. Sono, infatti, le istituzioni. Quelle d’ordine immanente che l’uomo e la storia ripropongono o inventano. Non sono tutte uguali, anche quando hanno il medesimo nome. Né tutte garantiscono eguali libertà. Permane, tuttavia, in rapporto ad esse, il fatto che la libertà può reperirvi un termine di riferimento, un metro con cui valutarle, una libertà, necessariamente relativa: la parola. Confrontato con l’istituzione, il campo della libertà si restringe, ma trova un tratto in cui potere specificarsi, circoscriversi. La libertà, nell’istituzione, diventa, è essenzialmente la libertà di parola.
L’esperienza tragica dei totalitarismi lo conferma. Limitiamoci, solo per rapidità, ai due che hanno caratterizzato il secolo scorso. La lezione è sempre maledettamente attuale.
Il nazismo e il comunismo sono stati un’esemplificazione, non un assoluto. Tragicamente, infatti, essi hanno mostrato una deriva perversa della dinamica istituzionale. La loro demonizzazione non deve però far dimenticare come, a livelli più ridotti e sottili, ciascuna istituzione contenga al suo interno una vocazione, una sua inevitabilmente tentazione di stampo totalitario. Negarlo aprioristicamente significa supporre che, come spesso accade nella facile retorica politica, il totalitarismo sia sempre e solo quello degli altri. O, più esattamente, quello che, a specchio, si rigetta sugli altri: sull’avversario. Ciascuna istituzione pone le condizioni per l’instaurarsi di un totalitarismo in rapporto all’unità che sollecita attorno al suo ideale (la “mission”, come dicono i manager) e al gruppo di soggetti che mobilita. La compattezza dell’istituzione risponde, peraltro, di un’esigenza pratica, poiché garantisce, direttamente, della sua efficienza e, potenzialmente, della sua efficacia. La metafora della macchina rende bene l’idea. Esiste un’istituzione che non coltivi, il più delle volte esplicitamente, un simile obiettivo?
La libertà del singolo fa obiezione alla macchina. Essa costituisce, di per sé, una complicazione o un tempo di ritardo al miglior funzionamento dell’istituzione, specie quanto più la stessa è di dimensioni ampie. L’esigenza di omogeneità è, dunque, intrinseca all’istituzione. In cambio, essa non manca di corrispondere a chi vi aderisce un certo senso d’appartenenza, sicurezza, stabilità. Il totalitarismo è, dunque, l’ombra inquietante che ogni istituzione si porta appresso, sia perché sollecitata dall’alto, sia perché inseguita dal basso. I contenuti o le bandiere che l’istituzione esibisce hanno, in tal senso, ben poca importanza. Siano quelli tecnicisti della ragione burocratica o quelli romantici della passione e del desiderio. L’obiezione all’ambizione totalitaria dell’istituzione si presenta quindi come un elemento di inciampo al suo dispiegarsi, come un tratto suscettibile di introdurre un disfunzionamento, come un sintomo, per dirla tutta, nel corpo istituzionale. Il grado di libertà che, come l’acqua in una barca, l’istituzione può assorbire è limitato. Pena l’andare a picco dell’imbarcazione. Chi o cosa possono stabilire un limite, per il soggetto nella sua espressione, per l’istituzione, nella sua vocazione unitaria?
Nella dinamica istituzionale, Freud assegnava un ruolo essenziale al leader, sostituto simbolico del padre. Tuttavia, la sua centralità è subordinata all’esistenza di un’altra figura, che fa da perno su cui ruota l’istituzione: il nemico. E nella sua versione più commerciale, il concorrente. Che cos’è un’istituzione e, soprattutto, che cos’è un leader senza un nemico? Se non c’è, è obbligato a inventarselo, come condizione necessaria alla propria esistenza. Il leader organizza, all’interno dell’istituzione, quel che il nemico o, più esattamente, l’l’immaginarizzazione del nemico mobilita. La retorica dell’ideale riveste e nobilita l’accanimento pulsionale. Una volta avviato il motore chi lo ferma, chi lo alimenta? E’ il leader che suggestiona le masse o sono le masse che sospingono gioiosamente il capo (e loro stesse) sull’orlo del precipizio? Chi fa godere e chi è goduto?
Lo Stato scrive lo stesso Freud “ha interdetto al singolo l’uso dell’ingiustizia, non perché intenda sopprimerla, ma solo perché vuole monopolizzarla”. Forse non è un caso che il leader sia più spesso un folle che un padre: uno psicotico brillante, dalla parlantina sciolta e disinibita.
Uno, cioè, che va oltre il limite e che affascina gli inibiti, vale a dire i nevrotici, proprio per questo. Lui dà la stura all’entusiasmo, li fa godere. Si pone come l’individuo che promette di realizzare il sogno che i frustrati tengono sottochiave nei loro fantasmi. Il giovanilismo non ha età ed è sempre la miglior benzina. Si ricordi Pol Pot: datemi due milioni di adolescenti, aveva detto, e costruirò il Paese.
Il folle esaspera un dualismo semplificato. Sei con me, come me oppure contro di me. Sei un clone o un nemico. La logica stringente è quella, politicamente feconda, della paranoia. Non ci sono, a lungo andare, grandi variazioni sul tema. Da qui le restrizioni che la libertà individuale necessariamente incontra, ora con sofferenza ora con, ribadiamo, corrisposto entusiasmo. Non c’è totalitarismo, senza consenso. L’esercizio della parola vi paga il suo prezzo, quando il singolo ne riconosce l’impellenza.
Nei casi più consueti, è lo stesso pensiero a ritrovarsi inoperoso. L’individuo è talmente affascinato dal delirio istituzionale che il leader e il gruppo congiuntamente e amorevolmente inseguono da non riuscire mentalmente a distaccarsi. Effettivamente, allora, la questione di una presa autonoma di parola non si pone nemmeno, nella misura in cui, realisticamente, non è neppure pensata, neppure avvertita come esigenza. Va bene così. E’ solo successivamente, quando ad esempio il soggetto esce dall’istituzione o la suddetta crolla, che se ne rende conto. Ma, ormai, il tempo è passato.
Nella Germania nazista, l’ossessione di Hitler e dei suoi numerosissimi ed eccitatissimi fans si organizza intorno al processo di distruzione di un Altro, costruito e inventato all’occasione. L’ebreo è l’incarnazione assoluta, non bisogna infatti andare troppo per il sottile, del male. E’, concettualmente, il paradigma più elementare. L’Altro che caratterizza il nemico lo è per il semplice fatto di essere tale, cioè ebreo. Non per quel che dice o fa. Lo è ontologicamente. Non può cambiare, non può convertirsi. La sua identità è marchiata alla sua origine, indipendentemente dalla sua posizione personale. Non c’è, dunque, scampo. Né parola che valga. L’improduttività della caccia agli ebrei, la profonda stupidità dell’operazione libera la ferocia pulsionale che amalgama la nazione. Un capo, un popolo. Ma, soprattutto, un nemico. La soluzione finale riecheggia i fantasmi bellicosi di Clausewitz sul termine della guerra.
Avanzo un’ipotesi. Anziché leggere, come in genere si fa, i due totalitarismi che hanno caratterizzato il Novecento in opposizione l’uno all’altro, perché non coglierli sulla base di una stretta continuità quanto meno logica? Il totalitarismo comunista, fatte salvo le debite differenze, non è forse un totalitarismo che è stato, a suo tempo, vittorioso? Esso emerge da una rivoluzione che con inaudita violenza (cioè per il tramite dell’assicurazione di un godimento di massa) ha eliminato il suo Altro, il suo nemico: lo zar, i nobili, ricchi, clero o piccoli proprietari terrieri.
L’Altro è, qui, in prevalenza un Altro storico, contingente. Anche se il furore rivoluzionario non è sempre attento a simili finezze. Il discorso, alla resa dei conti, non cambia poi molto. Uccisi gli sfruttatori, chi ne prende il posto? Il nemico (di classe) non c’è più. La vittoria instaura un nuovo ordine, quello tra i pari. O, per lo meno, così dovrebbe. Almeno in teoria. Ma come può, ora, la nuova istituzione, il nuovo stato sopravvivere senza un nemico? E’ a questo punto che la dinamica totalitaria si rimette in moto. Non sarebbe stato lo stesso se, ci terrorizza solo l’idea, la Germania nazista avesse eliminato il male, abolito ogni ebreo dalla faccia della terra, conquistato il mondo? Chi sarebbe stato allora il nemico? La rivoluzione russa lo mostra. Logicamente è, per così dire, il secondo giro del totalitarismo, dopo che il primo è stato esaurito. Chi è ora il nemico? Non è più una figura esterna, estranea o resa tale. Il nemico è potenzialmente chiunque. Essenzialmente, è colui che può essere bollato con lo statuto di “ex”. In altri termini, un piccolo altro (lettera miniscuola) che ci si sforza di fare diventare un vero Altro. E’ un ex, un amico diventato nemico. Tanto più nemico, quanto più, in precedenza, amico, compagno. I motivi possono variare. E’ troppo a sinistra, è troppo a destra, è troppo… Il valzer macabro prosegue.
Gli intellettuali vi partecipano, democraticamente come tutti. Magari vi aggiungono quel “in più” di enfasi che non guasta, quell’ubriacatura ideologica che dà al consenso beota un certo non so che di snob, di concettualmente raffinato e capzioso. Ogni totalitarismo ha avuto i suoi immorali sponsor; a destra, si pensi a teorici del calibro di un Heidegger o di uno Schmitt, come a sinistra: la lista è, qui, troppo lunga. Sono pochi quelli che hanno intuito, che hanno testimoniato, che hanno denunciato, che hanno pensato con la propria testa, sfidando l’omertà e l’impopolarità. Una manciata di nomi, niente di più: Simone Weil, George Orwell, Victor Serge, Albert Camus, Ignazio Silone…
Il secondo totalitarismo, d’altronde, pone una questione più complessa rispetto al primo. Nasce intorno a un’ideale di redenzione, si appoggia a una teoria solida. Ma poi? Nel primo totalitarismo, quello nazista, è difficile prendersi il coraggio di osare la propria libertà. Cioè, di andarci contro. L’esempio luminoso ed eroico è quello di Dietrich Bonhoeffer. Nel secondo caso, il meccanismo è, all’apparenza, contorto, imprevedibile. Fatica a riassumersi in un “no”. I confini sono mobili. La parola tentenna, il singolo può sentirsi diviso, incapace a difendersi dalla minaccia degli altri. Il dramma esterno è più suscettibile di riflettersi, kafkianamente, in uno interno. Forse, si dice l’individuo, sono io a sbagliarmi, come posso dubitare dell’amico di tante lotte e avventure? Avrò tradito la purezza degli intenti originari? Sarò io il nemico, l’ostacolo? Non sento già, dentro di me la voce irritata di un pari che, passandomi dolcemente un braccio sulla spalla, mi dice, quasi confidandomi deluso, “da te, non ce lo saremmo mai aspettato”?
La diffidenza regna, in tal caso, sovrana. Chi si prende l’onere di parlare, sfidando la minaccia dell’accusa più infamante? Non quella di essere contro, ma quella di aver tradito, di aver pugnalato alle spalle, – ah, il vigliacco – la fiducia, l’amicizia riposta in lui. La libertà è chiamata a schierarsi in opposizione non più a un discorso ottuso e liberticida ma a un ideale condiviso, a un sentimento amichevole (o supposto tale), in un clima prossimo alla degenerazione del tutti contro tutti, alla maldicenza generalizzata, al sospetto continuo. Chi osa? Chi non è lacerato dal dubbio, chi non è costretto, a sua volta, a odiare per raggiungere la libertà necessaria a proferire una parola?
In genere, per salvare gli altri e l’immagine di se stesso, nel proprio intimo e presso gli (ex) amici, non rimane che una strada: andarsene. O auto condannarsi sintomaticamente alla clandestinità, all’esilio. Come Trotsky. Non era lui che aveva giustamente detto che il vero problema della rivoluzione è il giorno dopo? Appunto.
Povera libertà, insomma. Lo spirito romantico la esalta. Le dà i nomi più disparati e la spinge a infilarsi un po’ dovunque, sino a generare gli esiti più infausti. L’istituzione impone un limite, ma, nel contempo, in parallelo offre un’occasione di risarcimento in cui la libertà nel senso più nobile del termine, può dimenticare se stessa. E’ il motivo per cui ci si lamenta dell’istituzione, ma poi ci si rimane attaccati, anche quando non sarebbe il caso. Specie quando è perversa, il godimento che assicura è impagabile. Il limite è aggirato nell’istituzione medesima, grazie all’istituzione stessa. Sono le meschinità, le rivincite, le rendite, le mafie che essa (ci) garantisce. Le complicità incestuose che regala. Il suo lato oscuro che è, poi, solo lo specchio del nostro. L’omicida, nell’esercito, può essere un eroe. Dipende. Il totalitarismo fa leva su un’ambiguità a cui, paradossalmente, non è estranea l’ansia di libertà. La fascinazione immaginaria. La parola può così attendere. La fame di libertà può appagarsi di molto meno, perdersi baldanzosamente in tragitti pericolosi. Dentro un ritmo anfetaminico che assorda e conquista. Per questo i muri finiscono per raccoglierne l’appello, confuso e veritiero, che abita in ciascuno e che nessuno riesce mai adeguatamente a formulare, a sostenere con la chiarezza e la dignità necessaria. E a dirselo fino in fondo.
Di Ezra Pound, Primo Levi affermava: sarà anche un grande poeta, ma ragiona male. Distinzione essenziale. Utile. Si possono poi leggere, con piacere, i Cantos. L’importante è saperlo: “Keep on rockin’ in a free world”.
*Psicologo Psicoanalista