La carenza di docenti STEM nella scuola italiana: origini e criticità del fenomeno
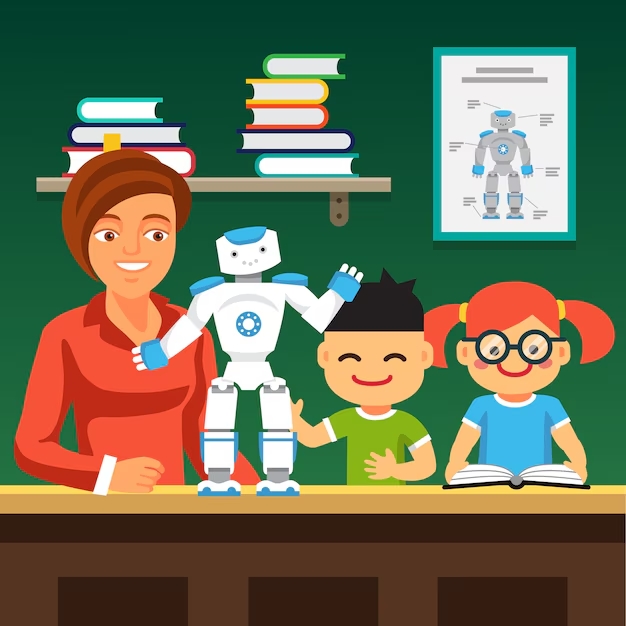 di MATTEO PLACIDO
di MATTEO PLACIDO
Professore a contratto di Digital Risk Analysis, Facoltà di Economia, Management e Territorio, Università degli Studi di Foggia.
Il tema del reclutamento e della formazione del corpo docenti nel nostro paese appare piuttosto articolato, presentando peculiarità che lo distinguono da altri paesi. Una discrepanza rilevante si riscontra nelle politiche di reclutamento che non seguono un percorso ben definito ma talvolta sono state implementate celermente in risposta ad emergenze periodiche e strutturali. Nel contesto delle recenti riforme per l’istruzione, il Decreto Legge 36/2022 così come modificato dalla legge 79/2022 ha previsto l’attivazione di specifici percorsi di formazione volti al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Il DL 75 del 22 giugno 2023, convertito con la Legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicata il 16 agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale, è intervenuto sulla materia insieme al D.P.C.M.[1] del 4 agosto 2023, definendo il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Successivamente, con Decreto Ministeriale n. 621 del 22-04-2024 sono stati autorizzati i posti e le modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’A.A. 2023/2024. Il DPCM rappresenta un punto di svolta al fine di ripristinare di un sistema di reclutamento definito e regolamentato, in sinergia con le istituzioni universitarie e accademiche che già da un decennio non prevedeva più forme di abilitazione o di formazione iniziale per il personale docente in Italia. Nel corso del tempo, i processi di reclutamento e formazione dei docenti in Italia hanno attraversato numerosi cambiamenti: inizialmente, è stato istituito un sistema di reclutamento sistematico a partire dalle SSIS (Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) dall’A.A. 1999/2000 e attive fino al 2008/2009, successivamente sono stati istituiti i TFA (Tirocinio formativo attivo) e i PAS (Percorsi abilitanti speciali), fino alla programmazione dei recenti percorsi previsti dal Decreto Legge 36/2022 e dal DPCM del 4 agosto 2023. Le nuove modalità per la formazione e il reclutamento dei docenti sono state formalmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023. Queste regolamentazioni sono state introdotte per allineare il sistema educativo italiano agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La riforma stabilisce un percorso in tre fasi per l’accesso al ruolo di docente a tempo indeterminato:
- Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale: questo percorso deve comprendere almeno 60 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), come stabilito all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
- Concorso pubblico nazionale: il concorso è indetto su base regionale o interregionale e rappresenta la seconda fase del processo di reclutamento.
- Periodo di prova in servizio: questa fase prevede un anno di prova con un test finale e una valutazione conclusiva.
L’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale è dettagliata nell’Allegato 1 del DPCM del 4 agosto 2023. Essa si compone di non meno di 60 CFU o CFA[2], suddivisi tra varie attività didattiche e di tirocinio. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, è richiesto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari ad almeno dodici ore. Quanto agli insegnanti della Scuola Secondaria di I e II grado, questi devono conseguire i 60 CFU, di cui almeno 20 attraverso un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto[3]. La riforma nasce con la volontà condivisa di porre rimedio all’annosa difficoltà di superare il precariato storico del corpo docente italiano: attualmente le stime sul numero di docenti precari si attestano intorno a 234.576, passando dal 12% al 24%, un dato significativamente superiore alla media europea, che si attesta intorno al 15%[4]. In aggiunta alle sintomatologie riconducibili a burnout ed esaurimento emotivo, l’instabilita lavorativa incide sulla qualità dell’insegnamento, limitando la continuità didattica e disincentivando le nuove generazioni ad intraprendere la carriera di insegnante, minata già da tempo da una considerazione publica controversa e da una valorizzazione economico-professionale ancora non definita. Tuttavia, nonostante i tentativi di regolamentazione, il reclutamento degli insegnanti presenta ancora diverse criticità, in particolar modo per le discipline STEM, per le quali pedissequamente ad ogni nuovo inizio di anno scolastico, si manifesta un’indisponibilità di docenti regolarmente titolati per ricoprire la cattedre vacanti residuali dopo le operazioni ordinarie di mobilità, immissione in ruolo e assegnazione a tempo determinato.
La crisi delle iscrizioni ai corsi di laurea STEM
Un fattore contestuale che evidenzia una difficoltà manifesta anche nell’insegnamento, è rappresentato dal più basso tasso di laureati in discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) in Italia, rispetto la media europea. Il divario territoriale di conoscenze e competenze acquiste nelle suddette discipline tra Nord e Sud è evidente già dalla scuola secondaria, con punteggi medi INVALSI che segnalano una differenza crescente tra le regioni settentrionali e quelle meridionali[5]. Secondo il rapporto INVALSI 2023, la distanza nei risultati di matematica tra le scuole del Nord e quelle del Sud è aumentata di 14 punti negli ultimi dieci anni, con una maggiore criticità nelle scuole secondarie di secondo grado[6]. Nonostante l’aumento delle immatricolazioni negli ultimi anni, l’Italia fatica a soddisfare la domanda del mercato del lavoro, che richiede sempre più competenze in intelligenza artificiale, data science e ingegneria. Il rapporto Osservatorio Fondazione Deloitte già nel 2020 evidenziava che il 23% delle aziende italiane non riesce a trovare personale qualificato in ambito STEM, in particolare ingegneri meccanici, informatici e dell’automazione[7].
La carenza di iscrizioni ai corsi STEM: dal ruolo dell’orientamento ai pregiudizi di genere
Benchè tale scenario in prima istanza appare riconducibile esclusivamente ad una difficoltà metodologica nello studio e nell’approccio di tali discipline, le implicazioni che dissuadono dall’iscrizione ad un corso di laurea STEM sono multifattoriali e di natura variegata. Gli studenti che decidono di non scegliere un percorso di laurea scientifico o tecnologico, affermano di aver manifestato interesse ma di aver abbandonato l’idea in seguito alla mancanza di appealper la professione ambita e per averli valutati estremamente complessi, soprattutto in linea riguardo gli studi pregressi. Le cause da associare alla percezione eccessiva di complessità possono in parte essere ricondotte a bias cognitivi e stereotipi impliciti ed espliciti riguardo le professioni STEM. Gli stereotipi impliciti sono associazioni che avvengono a livello inconscio e possono essere indesiderati. Sono un prodotto di convinzioni sociali e sono correlati, ma distinti, a stereotipi espliciti[8] . Tra i più comuni, si annoverano quelli per cui molte persone vedono le STEM come un dominio maschile) e di conseguenza le donne possono essere meno motivate a perseguire tali campi di studio. Un ulteriore fattore di distanziamento può afferire alla stereotipizzazione di studenti e professionisti STEM come socialmente imbarazzanti, poco attraenti, e naturalmente intelligenti. In uno studio in cui si chiedeva a studenti universitari di descrivere il prototipo di informatico o di ingegnere, i descrittori maggiormente indicati rimandavano a variabili quali introversione, mancanza di atletismo e intelligenza[9]. Anche nelle donne si manifesta la possibilità di indicare caratteristiche e modelli stereotipati e non si può escludere che ciò possa influire nella motivazione verso le discipline STEM. La pressione esercitata dal nucleo familiare sembra incarnare un ulteriore elemento di condizionamento nella scelta del percorso scolastico ed universitario: il ruolo dei genitori risulta determinante nello sviluppo della vita scolastica di un ragazzo.
Henderson e Berla[10] hanno suggerito che il fattore contribuente al successo dello studente non rimanda esclusivamente allo status economico o sociale ma alla misura in cui la famiglia di quello studente è in grado di essere coinvolta, interessarsi, creare un ambiente domestico che incoraggi l’apprendimento tra gli studenti ed essere coinvolti nel processo educativo del figlio presso gli istituti di istruzione. Inoltre la presenza della famiglia è importante per il coinvolgimento dei ragazzi che si tradurrà in una personalità ben sviluppata, forte e produttiva (Duran et al., 2010). Nel caso italiano, anche le famiglie sono soggette a influenze dovute ad una radicata cultura italiana prevalentemente umanistica, conducendo talvolta verso scelte sulla base di valutazioni e necessità personali. Decisivo si rivela il ruolo delle attività di orientamento scolastiche ancor di più negli ultimi anni della scuola secondaria di II grado: l’Italia manifesta un’ingente criticità trascurando la sinergia con aziende ed imprese. Difatti, esclusivamente un terzo degli studenti (36%) ha potuto partecipare ad attività di orientamento e solo uno su quattro (27%) è soddisfatto delle opportunità di conoscenza proposte (Fondazione Deloitte, 2020). Il primo passo verso una concreta sensibilizzazione del tema riguardante le STEM, consiste nel potenziare la consapevolezza dei bisogni economici e di mercato sia tra gli studenti che tra le famiglie, sostenendo i ragazzi nell’approccio strumentale e metodologico allo studio di tali discipline.
Quali scenari educativi nelle STEM?
Per far fronte a questa crisi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto nel 2023 le Linee Guida per le Discipline STEM, che prevedono un incremento delle ore dedicate alle materie scientifiche nella scuola primaria e secondaria, corsi di aggiornamento per i docenti e incentivi economici per gli studenti che scelgono percorsi scientifici[11]. Alcuni studi hanno già constatato l’importanza delle competenze STEM fin dalla prima infanzia per i risultati successivi nei soggetti impegnati in studi scientifici[12]. Tuttavia, coesistono alcune serie di fattori che possono alterare le traiettorie educative a lungo termine dei risultati STEM dei bambini, compresi i cambiamenti nella motivazione e nelle pratiche in classe, e il fallimento o il successo nel raggiungimento delle competenze chiave durante gli anni scolastici[13]. In aggiunta a tali misure, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha destinato 660 milioni di euro per il potenziamento dell’insegnamento STEM, con la creazione di laboratori avanzati e percorsi di formazione specifici per gli insegnanti. Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipenderà dalla loro implementazione e dalla capacità di attrarre un numero maggiore di studenti verso le discipline scientifiche. Un’ulteriore strategia riguarda il miglioramento dell’orientamento scolastico: in Italia, solo il 30% degli studenti riceve informazioni dettagliate sulle opportunità di carriera legate alle discipline scientifiche, rispetto al 50% in Germania e al 60% nei Paesi Bassi[14]. L’introduzione di percorsi di tutoraggio e collaborazione tra scuole e aziende potrebbe migliorare la consapevolezza degli studenti e favorire un maggiore interesse per le STEM. In conclusione, la riforma del reclutamento degli insegnanti e la crisi delle iscrizioni a corsi di laurea STEM sono due aspetti interconnessi di un problema più ampio e complesso. Un sistema educativo più efficace, in grado di programmare il fabbisogno di docenti e di promuovere un’adeguata preparazione scientifica fin dalla scuola primaria, è essenziale per garantire un futuro più competitivo per il paese e per lo sviluppo tecnologico e professionale.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
[1] Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri (4 Agosto 2023); Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (23A05274) (GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)
[2] Ad eccezione dei percorsi da 30 cfu ex. art. 13 per i quali non è prevista un’indagine di fabbisogno territoriale e di autorizzazione nei limiti di posti disponibili, bensì dall’accreditamento da parte del MUR circuito alle sole classi di concorso.
[3] DPCM 4 agosto 2023, “Disposizioni sui percorsi abilitanti”.
[4] Istat, “Situazione del personale docente in Italia”, 2022.
[5] INVALSI, “Rilevazione degli apprendimenti”, 2023.
[6] Fondazione Rocca, “Scuola, i numeri da cambiare, 2023.
[7] Osservatorio Fondazione Deloitte, “Regeneration STEM”, 2020.
[8] Nosek, B. A., Smyth, F. L. (2007). A multitrait-multimethod validation of the Implicit Association Test: Implicit and explicit attitudes are related but distinct constructs. Experimental Psychology, 54, 14–29.
[9] Ehrlinger, J., Plant, E. A., Hartwig, M. K., Vossen, J. J., Columb, C. J., Brewer, L. E. (2018). Do gender differences in perceived prototypical computer scientists and engineers contribute to gender gaps in computer science and engineering? Sex Roles, 78, (pp. 40–51). https://doi:10.1007/s11199-017-0763-x
[10] Henderson, A. & Berla, N., Eds. (1994) ? New Generation of Evidence. The Family Is Critical to Student Achievement. National Committee for Citizens in Education, Washington DC.
[11] Ministero dell’Istruzione e del Merito, “Linee Guida per le Discipline STEM”, 2023.
[12] Johnston, J., (2011). The impact of home and school on early years scientific development. Education in Science, 245, (pp. 30–31).
[13] Watts, T.W., Duncan, G.J., Siegler, R.S., & Davis-Kean, P.E., (2014). What’s past is prologue: Relations between early mathematics knowledge and high school achievement. Educational Researcher, 43 (7), (pp. 352–360).
[14] Eurostat, “Educational and Career Guidance in Europe”, 2022.

