Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli
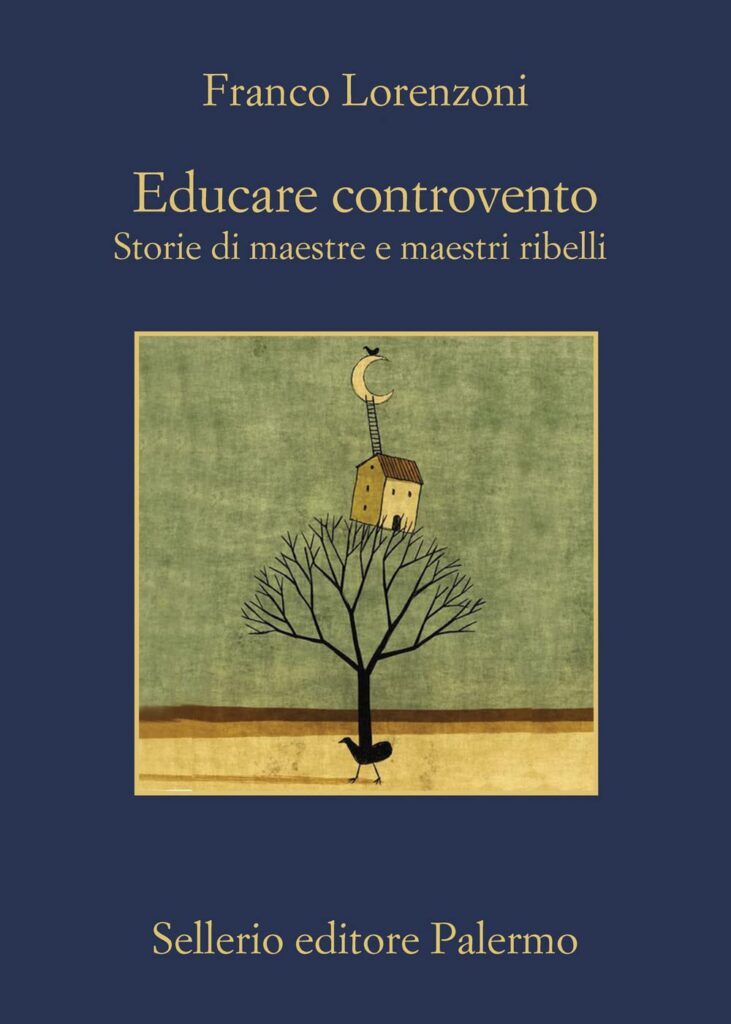 Franco Lorenzoni
Franco Lorenzoni
Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli
Sellerio Editore, Palermo, 2023, pp. 256, € 16,00
Franco Lorenzoni, maestro elementare, ricercatore e formatore, ha fatto parte del Movimento di Cooperazione Educativa ed ha fondato nel 1980 ad Amelia, in Umbria, un centro di sperimentazione, la Casa-laboratorio di Cenci. Recentemente (nel 2021) ha ricevuto due lauree honoris causa, una dall’Università Bicocca di Milano e una dall’Università di Palermo.
Come l’autore stesso dice, «Questo libro ha due andamenti che si alimentano reciprocamente». Nei capitoli dispari si parla di temi educativi, cioè di scelta, di corpo, di spazio, di tempo, di dialogo, di arte del convivere, di conversione ecologica. Nei capitoli pari si parla di persone, di maestre e maestri «che in epoche e contesti diversi hanno promosso ribellioni efficaci» ad approcci pedagogici indifferenti agli aspetti di cui sopra.
Nell’introduzione Lorenzoni presenta ciò che l’educare dovrebbe fare («liberare potenzialità, allargare gli sguardi, forgiare e mettere a punto conoscenze e strumenti in grado di moltiplicare le possibilità di scelta di ciascuno… ») e ciò che non dovrebbe mai porsi («pretendere di portare dove vogliamo noi») e afferma di aver imparato con l’esperienza «che la cooperazione, il ricercare insieme, lo scovare o creare contesti in cui condividere dubbi e domande sono alleati necessari per intraprendere la delicata opera di educare controvento, non accontentandoci di come va il mondo».
Svolge poi i diversi capitoli del testo presentando ampiamente i principi educativi in cui crede e le persone che, prima di lui, contemporaneamente a lui o insieme a lui, li hanno affermati e applicati.
Nei capitoli dedicati agli aspetti pedagogici per lui più rilevanti, Lorenzoni parte dal principio che basterebbe rispettare l’articolo 3 della costituzione per fare una buona scuola, una scuola che pone l’attenzione sul dare opportunità a tutte/i di apprendere e sul rimuovere eventuali ostacoli. Tratta poi dell’importanza del corpo nei processi di apprendimento, della necessità di coinvolgere soprattutto i più piccoli con esperienze che riguardino tutti i sensi e il movimento. E a questo si lega l’aspetto di come «abitare lo spazio», di come organizzarlo: «… il parlare in cerchio o da dietro i banchi, seduti a terra o sotto un albero in giardino» modifica l’attenzione, l’ascolto reciproco e l’espressione di pensieri. Di altrettanta rilevanza sono infine gli aspetti della cura della memoria, «a partire dalla memoria del corpo», della promozione del dialogo per «costruire cultura creando comunità», dello sviluppo dell’«arte del convivere» e della comprensione della «conversione ecologica» attraverso «uno studio della storia dell’intero mondo».
Nei capitoli dedicati alle maestre e ai maestri, da cui l’autore dice di avere imparato e/o con cui ha collaborato sia a livello di ricerca sia a livello di sperimentazione, sono presentate le figure di Piero Calamandrei, che si dedica con estrema attenzione all’«ascolto delle prime parole di suo figlio»; di Alessandra Ginzburg, che «si ribella alla segregazione in cui erano costrette a vivere bambine e bambini con disabilità»; di Emma Castelnuovo, che si oppone con forza «a un insegnamento della matematica che avvilisce le intelligenze invece di esaltare le capacità di scoperta di tutte e tutti»; di Nora Giacobini, che «si ribella all’etnocentrismo occidentale», dimostrando «vicinanza con i più fragili e i vinti»; di Mario Lodi, che si dichiara decisamente contrario «a una scuola che nega la parola a bambine e bambini»; di Don Lorenzo Milani, che denuncia il voler «confinare i poveri» nell’ignoranza; di Alexander Langer, che si leva contro «ogni accettazione passiva delle segregazioni etniche»; di Malala Yousafzai, che si fa «paladina della libertà di istruzione delle donne»; di Greta Thunberg, «che si ribella alla sottrazione di futuro di cui sono responsabili le generazioni adulte che governano il mondo».
Essenzialmente Franco Lorenzoni ritiene improrogabile modificare «le nostre pratiche educative» affinché «ogni scuola diventi luogo di creazione culturale, perché il sapere di cui abbiamo bisogno ancora non c’è e va elaborato in più contesti possibili e in primo luogo nella scuola pubblica».
Margherita Mainini

