La rabbia del vento
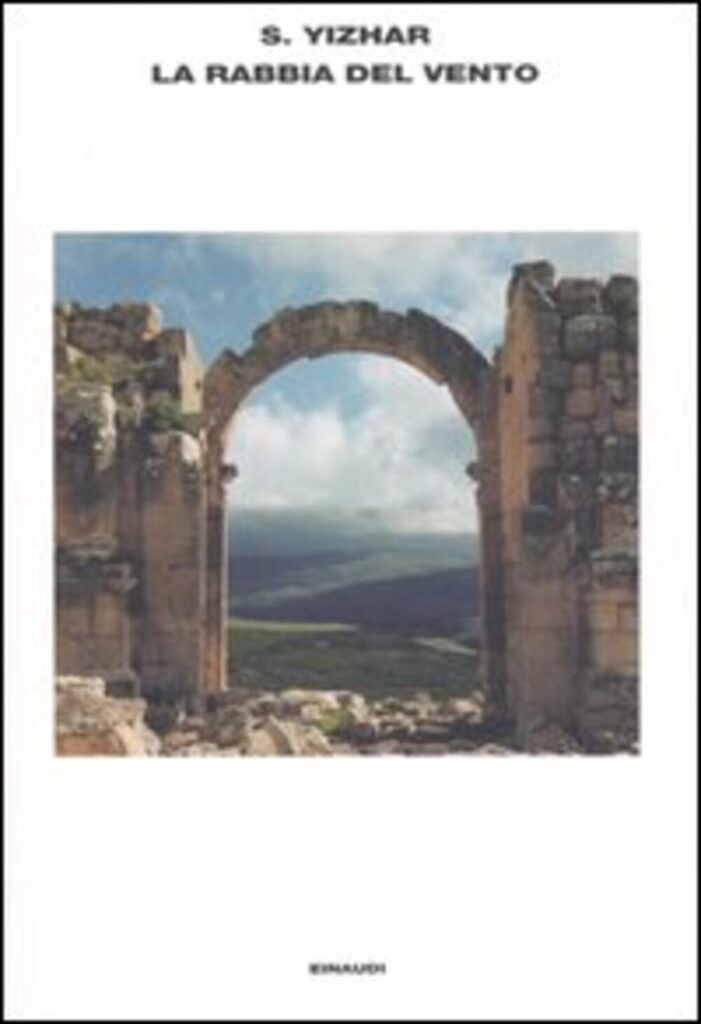 Yizhar
Yizhar
La rabbia del vento
Giulio Einaudi Editore, Torino 2005, pp. 85, € 10
Yzhar, pseudonimo di Yzhar Smilansky, è considerato in Israele il padre della letteratura ebraica moderna. Nato da immigrati russi nel 1916 in quella che allora era la Palestina ottomana, faceva parte di quella nuova generazione che non aveva conosciuto l’esilio e che attendeva con speranza la nascita della nuova nazione. Durante la guerra arabo-israeliana del 1948 è stato ufficiale dell’Intelligence e poi membro della Knesset e docente universitario.
È il maggio del 1949 quando scrive questo racconto, un anno dopo la proclamazione del nuovo stato e sul finire di quella guerra, che per gli Israeliani era una guerra di liberazione, per i palestinesi, invece, la Nakba, ovvero la catastrofe.
Il libro fu pubblicato nello stesso anno, divenne un best-seller tanto da essere inserito nel curriculum delle scuole superiori e in seguito fu al centro di controversie che ne indebolirono la fama. Fu tradotto in Europa solo negli anni duemila.
La storia si svolge nell’arco di una giornata e narra di un reparto dell’esercito Israeliano inviato a sgomberare l’immaginario villaggio palestinese di Khirbet Khizeh. L’io narrante, di cui non si conosce il nome, è uno dei giovani militari, verosimilmente alter ego dell’autore.
Il reparto si mette in marcia con ordini precisi così sintetizzati «bruciare-fare esplodere-arrestare-caricare-trasferire […] con fermezza e precisione». La missione è vissuta dai soldati senza particolare trasporto; semplici ordini da eseguire, senza porsi troppe domande, del resto stanno solo tornando alla loro “casa ancestrale”, poco importa se «quella banda di arabi pezzenti e codardi» ne pagherà il prezzo. Solo il protagonista si sente a disagio per questa operazione che considera profondamente ingiusta. Cerca di condividere i suoi dubbi con i compagni, ma nessuno lo ascolta. Isolato in una sorta di esilio spirituale inizia a dialogare con se stesso dando vita ad un conflitto interiore, doloroso e lacerante, tra il dovere di ubbidire agli ordini e la propria coscienza che si ribella. Sono pagine strazianti, nelle quali il protagonista interroga se stesso analizzando con lucidità, ma anche con intensa partecipazione emotiva ed amara ironia, gli eventi, i comportamenti ed anche i luoghi in cui tutto si consuma, trascinandoci in un flusso di coscienza che raggiunge il suo apice nel momento in cui il plotone entra nel villaggio; nessuna resistenza, solo un immenso silenzio e le cicatrici inflitte dalla guerra: campi incolti, animali abbandonati, case lasciate in fretta, nelle quali tutto, oggetti, utensili, arredi ormai inutilizzati ci parlano di vite spezzate, di una quotidianità bruscamente interrotta, di intimità violate. I pericolosi nemici sono solo donne, bambini, anziani, disabili, un’umanità spaventata, sottomessa, implorante, inascoltata, inconsapevole del destino che la attende. Le case vengono fatte esplodere, le capanne bruciate, le persone raccolte per essere fatte salire su camion la cui destinazione è ignota. Gli sguardi impauriti dei bimbi, le lacrime che scorrono silenziose sui volti delle madri, le urla di chi vede distrutta la propria casa, le timide richieste di qualche anziano messo brutalmente a tacere, la dignità nella disperazione oltraggiata dai modi disumani e sprezzanti dei militari. Vergogna! È quello che prova il protagonista sentendo su di sé tutta l’umiliazione e il dolore di un popolo costretto all’esilio, lo stesso esilio, che aveva portato tanti ebrei perseguitati in Palestina. Le vittime sono diventate carnefici. Con angoscia e indignazione crescenti capisce che in quel nuovo paese, fondato sull’odio, non si sarebbe più sentito “a casa” e che questo inizio brutale avrebbe segnato per sempre il futuro d’Israele e tormentato la sua coscienza per molto tempo.
Profeta in patria Yizhar, infatti, inizia il racconto immaginando di scriverlo molti anni più tardi, afflitto dai ricordi e spinto dall’esigenza di salvare questa storia dall’oblio e dalle menzogne. E la sua voce si leva potente, è l’urlo del popolo palestinese lanciato da un soldato ebreo, che ci riporta con violenza alla tragica realtà di oggi. La Shoah è un passato da non dimenticare, la Nakba è il passato che si perpetua senza fine nell’indifferenza.
Carla Franciosi

