Potere, soggettività, postmodernità
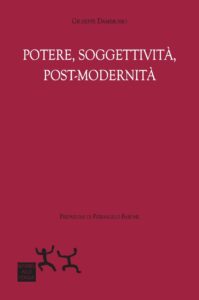
GIUSEPPE D’AMBROSIO
Potere, soggettività, post-modernità
Prefazione di P. Barone
Sensibili alle foglie, Roma 2021.
120 pp.
€ 13,00
Le analisi di Giuseppe Dambrosio in Potere, soggettività, post-modernità edito nel 2021 da Sensibili alle foglie si avviano, imprescindibilmente a mio parere, dagli studi di Michel Foucault e in particolare da Les Anormaux, per poi proporre aggiornamenti e approfondimenti sulle attuali dinamiche sociali, e le conseguenti percezioni individuali, nell’era del neoliberismo digitale e delle derive tecnocratiche. Le riflessioni dell’autore, anche grazie all’efficace sintesi espositiva, ci introducono all’esplorazione di terreni differenti ma intrecciati fra loro perché pianificati per ottenere sempre maggiori strumenti di controllo, soprattutto attraverso quell’addestramento all’autodisciplina che proprio Foucault ebbe modo di osservare. E allora ci si chiede quali forme di resistenza al potere si possano attuare se, più che trovarci di fronte ad esplicite limitazioni di libertà, saremo sempre più incanalati in una struttura sociale che vincola comportamenti e relazioni a tal punto da indurci a considerarla accattivante. Nel testo si intersecano così i contributi di vari autori (Augé, Bauman, Baudrillard, Benasayag, Frances, Laffi, Lazzarini, Massa, Palmieri, e di Pierangelo Barone, autore della prefazione) a testimonianza delle diverse implicazioni prodotte da questi cambiamenti epocali. Il libro è diviso in due parti: La medicalizzazione delle differenze, titolo della prima, analizza quanto il concetto di normalizzazione pervada le relazioni (soprattutto laddove si può instaurare un potere: medico/paziente, insegnante/allievo) e instauri un linguaggio giudicante, edificato su concetti ascientifici e arbitrari, in grado di allargare le maglie della rete di anomalie (patologie) creando discriminazione (psichiatrizzazione).
Scrive Dambrosio: “Poiché gli standard delle prestazioni sono aumentati in modo vertiginoso e gli stimoli esterni agiscono oggigiorno in modo continuativo e invasivo basta un sintomo di troppo per esser delineati come anormali e quindi assoggettabili a un trattamento farmacologico-rieducativo finalizzato al recupero o alla prevenzione continua della devianza e della marginalità sociale” (…) “Ne deriva la totale conformazione a un’intelligenza che non è altro che la capacità di disintegrarsi per conformarsi al sistema-azienda post-moderno.” Un sistema in cui l’unica modalità ammissibile corrisponde a “quella dell’homo consumens, docile e funzionale al sistema neoliberista dominante, in cui chi non rientra viene rieducato alla Norma”. E sul concetto di educazione e di pedagogia critica l’autore focalizza le sue energie per offrire spunti di dialogo sulle possibilità di contrapposizione al senso di impotenza collettiva per porre “fine al dispositivo di annichilimento della libertà del soggetto, per assumere quello di insegnamento dei modi attraverso cui l’individuo può praticare la libertà”. Assoggettamento e soggettivazione nell’epoca post-moderna è il titolo della seconda parte del libro: se Foucault inaugurò il concetto di “dispositivo” per identificare gli elementi strutturali del complesso sistema di condizionamento delle scelte, in tempi sempre più organizzati su algoritmi ed esasperazioni digitali siamo trascinati in una deriva spazio-temporale che coinvolge i nostri corpi, ne modifica le possibilità di azione e la percezione delle opportunità creando illusorie gratificazioni. Ecco allora che “non-corpo”, “non-spazio”, “non-tempo” si insinuano nelle quotidianità come astrazioni distopiche cariche però di attrattiva: a questi paradossi è essenziale dare forma e significato per coglierne le implicazioni più nefaste, per non esserne travolti e per riconoscere gli squilibri che ne derivano affinché i nostri corpi possano respirare in luoghi riconoscibili e concretizzare esperienze resistenti perché scandite su tempi ancora idonei al germoglio della memoria e alle progettualità future.
Chiara Gazzola

