Scelti per voi (Libri per tutti)
Rubrica a cura di Claudia Alemani
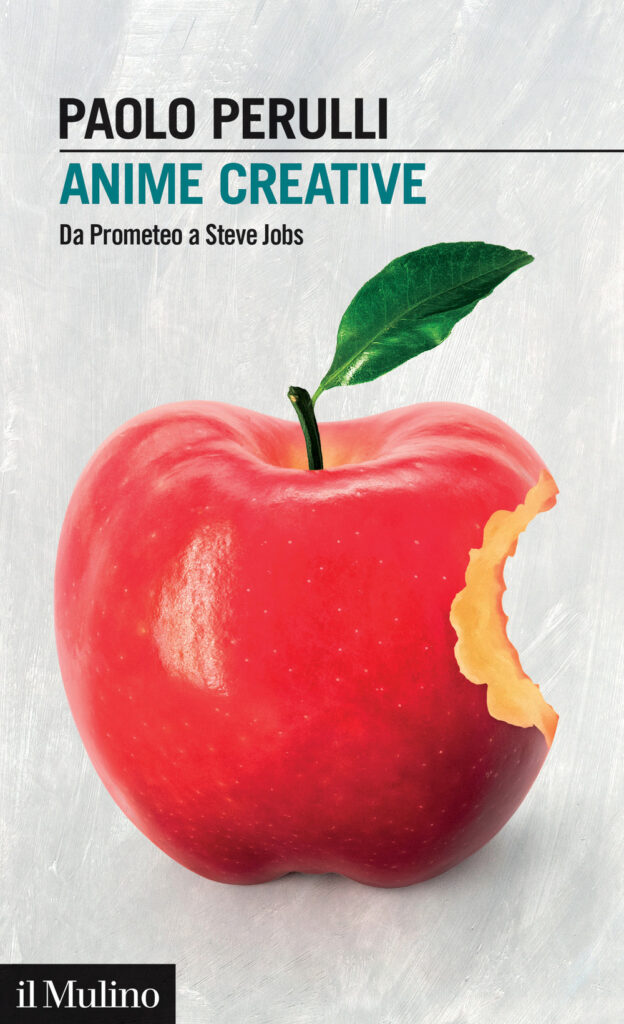 Paolo Perulli
Paolo Perulli
Anime creative. Da Prometeo a Steve Jobs
Il Mulino edizioni, Bologna 2024, pp. 217, € 17
Ho già segnalato due saggi di Paolo Perulli, sociologo dell’economia e docente all’Università del Piemonte Orientale. Avevo trovato interessante la sua analisi socioeconomica che ipotizzava e immaginava il futuro superando le difficoltà contingenti, partendo da una “classe creativa” in grado di progettare novità e ridare fiducia alla nostra democrazia (il riferimento è al testo Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo, ed. Il Mulino). Oggi l’autore sostanzia e storicizza il tema della creatività in un saggio che – attraverso le opere e le storie di intellettuali, artisti, scienziati, imprenditori visionari, avanguardie europee novecentesche – contribuisce a definire la figura del creativo e il suo spazio nell’epoca contemporanea.
Il saggio è “un viaggio nel tempo e nello spazio per capire come la creatività ha dato forma al mondo” ed ha in copertina una mela morsicata, dove il morso è un invito ad osare, immaginare e assaporare nuove possibilità. La creatività nella modernità si definisce partendo dall’esposizione di Parigi del 1885, che coinvolse le masse: attraverso eventi innovativi sviluppò processi di industrializzazione e si presentò come motore di sviluppo e di cambiamento, sociale e politico.
Una parte importante del libro riguarda l’approdo negli USA dei tanti intellettuali europei cacciati dal 1932 al 1941, in fuga dalle “follie” razziali del vecchio continente. In questa appartenenza tra vecchio e nuovo mondo si sono sviluppate ricerche in molti ambiti e l’apporto individuale partecipato ha portato sviluppo e benessere in vari settori: sia nell’arte, che nell’economia, per passare dall’architettura alla tecnologia. Sono state così avviate esperienze innovative. Ma qual è il portatore di innovazione? Sta nel termine anima, che l’autore antepone a quello di creativo: ciò è di particolare interesse e a me rimanda il genio innovatore di C.G. Jung che, nel libro Tipi psicologici, parla di anima – oscura e inconscia, mette in relazione le nostre parti interne con l’esterno e l’altro da noi – contrapponendola al termine persona. L’evento creativo parte da una crisi, da un momento di squilibrio interno/esterno, un disagio come quello che portò Jung ad allontanarsi da Freud per trovare il suo processo “individuativo”. Si oggettivano così le immagini inquiete e profonde del Libro Rosso (pubblicato postumo nel 2009 è stato esposto anche alla biennale di Venezia anni fa), diario del suo periodo di disagio psichico: tali immagini visualizzano il potere della psiche inconscia e il valore artistico dell’espressività di anima.
Con la sua “immaginazione attiva”, Jung ha reso possibile attraverso una metodologia di cura la visione creativa di futuro; ha dato forma a nuove figure collettive ed individuabili potenzialmente integrabili. Apertura a qualcosa di nuovo anche nella scoperta del “neutrino” di W. Pauli, che con Jung ha scritto sulla sincronicità, ovvero sull’incontro tra psiche e materia (si veda il loro carteggio del 1932).
Il lavoro degli alchimisti era un lavoro creativo solitario, partiva dalla materia confusa (nigredo) per arrivare all’albedo, alla “pietra filosofale”. La solitudine dell’alchimista sollecita una visione della figura del creativo come colui che sa immaginare e mantenere una coerenza interiore verso stimoli avversi. E allora il mito di Prometeo può sollecitare una riflessione sull’operare creativo. Il mito suggerisce che il furto del fuoco, così importante per gli umani, sia avvenuto nella fucina di Efesto, il dio precipitato negli inferi perché imperfetto, ma era lui che con il suo lavoro, solitario e sotterraneo faceva o creava “meraviglie”. Allora, per superare limiti e confini bisogna guardare anche altrove e aprire i confini. Nel capitoletto conclusivo dal titolo “Scenari futuri”, Perulli inserisce un importante paragrafo sui contenuti fertili che oggi potrebbero arrivare da nuove culture meticce e dal sud del mondo. Uno stimolo per ulteriori riflessioni e anche per una formazione alla creatività.
Emilia Canato
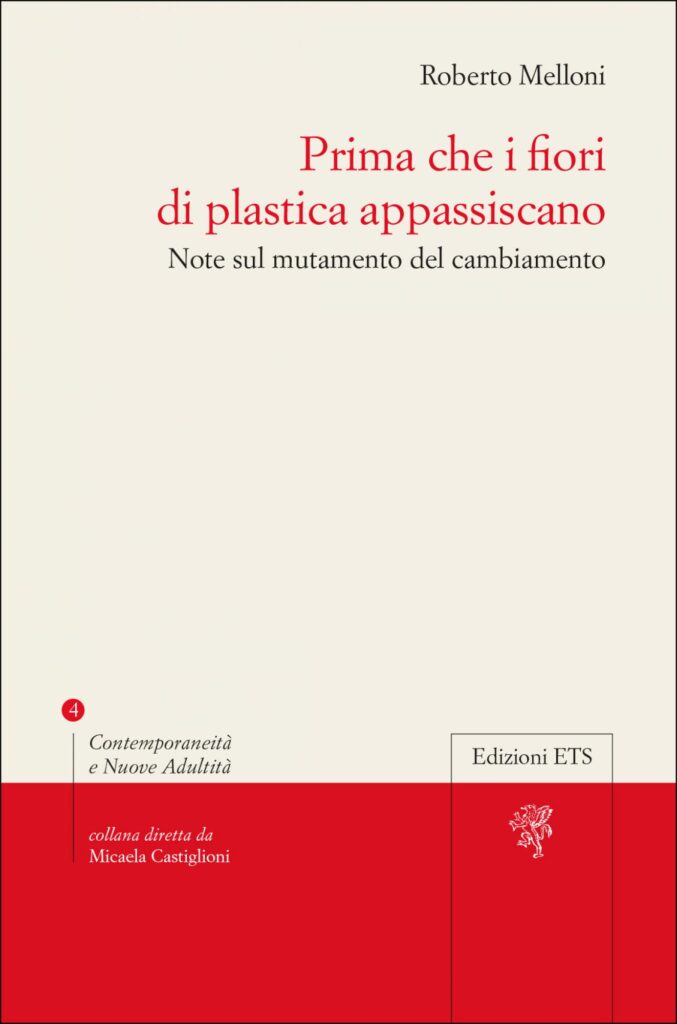 Roberto Melloni
Roberto Melloni
Prima che i fiori di plastica appassiscano. Note sul mutamento del cambiamento
Edizioni ETS, Pisa 2024, pp. 112, € 14
Metafora spiazzante quella che introduce e chiude l’eclettico, sfaccettato saggio di Melloni sulla confutazione delle false credenze e dei luoghi comuni del cambiamento che, come fiori di plastica, ci consiglia l’autore, non dovremmo perdere tempo a innaffiare. Meglio invece seguire il percorso di riflessione proposto dal libro che, intrecciando argomentazioni che contaminano scienze umane e scienze fisiche, sfruttando analogie con diverse discipline quali la filosofia, la narrativa, la musica, l’arte figurativa, mette in luce, con sguardo eccentrico, un cambiamento inteso come scelta di costante ripensamento, che crea e ricrea il percorso di vita. È questa la prima definizione del mutatocambiamento che emerge nella ponderosa introduzione al saggio. Altra complessità si farà strada nello svolgimento dei capitoli, dedicati ciascuno alla disanima dei classici modi di intendere il mutamento. Il tutto delineato su un ricchissimo sfondo che esplora, per rifiutarlo, quello che la storia e il progresso continuano a riproporci come modello di cambiamento: una corsa di movimento progressivo, diventata ora quasi frenesia, l’illusione di un mutare, cieco, che genera nel soggetto, alienazione. È, al contrario, nell’incertezza delle plurime dimensioni dell’accadere che si può rinvenire il senso della trasformazione, ci dice l’autore, in ciò stabilendo un inedito rapporto con quelli che secondo la meccanica quantistica sono i comportamenti delle particelle subatomiche. Rispetto alla fisica classica, che pensa la materia governata da leggi deterministiche, la teoria dei quanti ci dice che i movimenti delle particelle subatomiche avvengono in maniera probabilistica, che abbiamo la probabilità di trovare la piccola particella dell’atomo in un punto, solo se la osserviamo e che due particelle che si sono incontrate in passato rimangono in qualche modo legate anche a grandi distanze nel fenomeno misterioso dell’entanglement. L’interpretazione relazionale che la meccanica quantistica fa del mondo viene traslata da Melloni alle scienze umane, in particolare a una filosofia intesa come scienza dei vissuti, arricchita dalle riflessioni che derivano dalla pratica terapeutica dell’autore. È in questa analogia che si trova, a mio parere, una delle parti più interessanti del saggio, meritevole di ulteriori approfondimenti, mi auguro, in prossimi lavori dell’autore.
Vorrei ora tornare a mostrare come il testo di Melloni giunga a un sempre più approfondito e divergente concetto del cambiamento attraverso la disanima delle caratteristiche e degli strumenti che a esso vengono tradizionalmente ascritti. È così per quanto riguarda la dicotomia cambiamento/adattamento, già criticamente affrontata nell’acuta prefazione di Micaela Castiglioni, che viene qui ricomposta attribuendo alle scelte adattive non una mera funzione di sopravvivenza ma quella di percorso indirizzabile e valutabile guidato dall’autoconsapevolezza. Allo stesso modo alle attitudini che di solito vengono ritenute necessarie a produrre il cambiamento, come l’orgoglio e il carattere, viene preferita la competenza ricettiva dell’attenzione, capace di riflettere in purezza, come in un cristallo, ciò che sta dall’altra parte, ciò che è altro da noi.
Per mezzo di ulteriori successivi approfondimenti sui principali ostacoli al cambiamento, come la dipendenza e la volontà di potenza, si chiarisce progressivamente la domanda sostanziale sulla trasformazione personale, a cui il lettore cerca di trovare risposta in questo denso saggio: come cambiamo e se e come ci è dato indirizzare la nostra trasformazione? Voglio tentare una risposta finale, con l’ardire di una sintesi forse un po’ riduttiva, che spero mi sarà perdonata. La nostra capacità di cambiare si trova nel diventare autori di noi stessi e si realizza attraverso l’impegno che prendiamo, che matura nella presenza a sé, per creare e continuamente ricreare, nel tessuto della relazione, le possibilità di una vita di qualità.
Luisella Erlicher
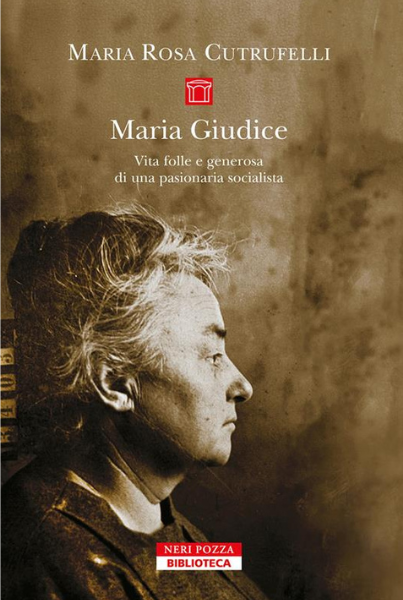 Maria Rosa Cutrufelli
Maria Rosa Cutrufelli
Maria Giudice
Neri Pozza, Vicenza 2024, pp. 155, € 14,00
Inverno 1991. In un salotto è riunito un gruppo di lettura. Nove scrittrici, che si ritrovano un paio di volte al mese per parlare di libri, letteratura, ma anche per commentare i fatti d’attualità. Tra loro l’autrice e Goliarda Sapienza, intime amiche. Quest’ultima sarebbe in procinto di scrivere un romanzo sui suoi genitori, progetto che non vedrà mai la luce, ma che riaffiora, a trent’anni di distanza, in questa potente e appassionata biografia della madre di Goliarda, Maria Giudice, nella quale Cutrufelli ci restituisce il ritratto di una donna straordinaria, che ha attraversato la storia del Novecento da protagonista e artefice, ma che oggi viene, ingiustamente, ricordata solo per essere la madre di Goliarda Sapienza. Si sa, le donne, soprattutto se ingombranti, scompaiono dalla narrazione storica, schiacciate da una società patriarcale e maschilista, che ne accetta e ne sfrutta il contributo, ma poi se ne dimentica.
Cutrufelli colma quel vuoto compiendo un atto politico oltre che letterario e lo fa in modo inedito e inaspettato perché questa non è solo una biografia, ma anche un’indagine che coinvolge il vissuto stesso dell’autrice che dà al racconto una dimensione profondamente intima ed umana. Così come quell’ “io”, che irrompe di tanto in tanto e che pone l’autrice in un rapporto dialettico di empatia e partecipazione con la sua protagonista.
Guidat* dall’osservazione di poche ma significative fotografie, dai ricordi e dalle parole della figlia Goliarda, ripercorriamo le tappe della vita di una ragazza di fine Ottocento che impara dal padre il senso morale della politica e dalla madre l’amore per i classici. Consapevole che l’istruzione e la cultura siano l’unica strada per l’emancipazione, studia a Pavia dove prende il diploma di maestra, un’unica possibilità per una donna dell’epoca di conseguire un titolo di studio superiore.
Da questo momento la sua vita è un fiume in piena.
Inizia a partecipare alla vita politica, abbracciando le teorie socialiste, decisa a portare avanti l’dea di un socialismo egualitario e umanitario nella lotta contro il potere, le ingiustizie e prevaricazioni, sempre in prima linea dalla parte degli operai, dei braccianti, delle donne, dei più deboli, della pace e della libertà.
Femminista a modo suo, prima donna a capo della Camera del Lavoro, prima donna segretaria del partito socialista, fondatrice e direttrice di giornali, abile oratrice, conosce l’esilio e spesso il carcere ed anche l’esperienza del ricovero in cliniche psichiatriche. Nella sua battaglia per l’emancipazione femminile e il pieno riconoscimento dei diritti civili e politici non mostra mai esitazioni, nemmeno quando deve contrapporsi ai suoi stessi compagni di partito. Sostenuta da una indomabile forza di volontà, affronta la sofferenza e la solitudine senza mai scoraggiarsi, senza mai venire a patti con il pensiero comune, né derogare alle sue idee e ai suoi principi. Viaggia senza sosta, infaticabile, per tutta la penisola, là dove il partito la manda, sino ad approdare in Sicilia, quell’isola che “è malia che trattiene” e che diventerà, per un lungo periodo, la sua casa.
In tutto questo mette al mondo dieci figli con due diversi compagni, senza mai sposarsi. L’amore non può essere ingabbiato da vincoli e il desiderio di maternità non può essere annullato dall’idea socialista. Ancora una volta la sua autonomia di pensiero si afferma al di sopra della “cultura barbuta”, quella maschilista, che vorrebbe la donna relegata in casa.
Seppure in modo non convenzionale, Maria ama tutti i figli e le figlie che ha avuto, ma sarà Goliarda, l’ultima, la sua prediletta, a prendersi cura di lei negli ultimi anni della sua vita. L’amore e la tenerezza che le unisce compenserà la fatica di sopportare l’idea che il fiume in piena si stia esaurendo.
Ed è a Goliarda, la sua amica, che l’autrice si rivolge nelle ultime pagine con un omaggio struggente, che chiude il cerchio intorno a una storia di battaglie e di coraggio che è in fondo la storia di tutte le donne dimenticate che hanno lottato e ancora lottano per conquistare il proprio diritto ad esistere.
Carla Franciosi
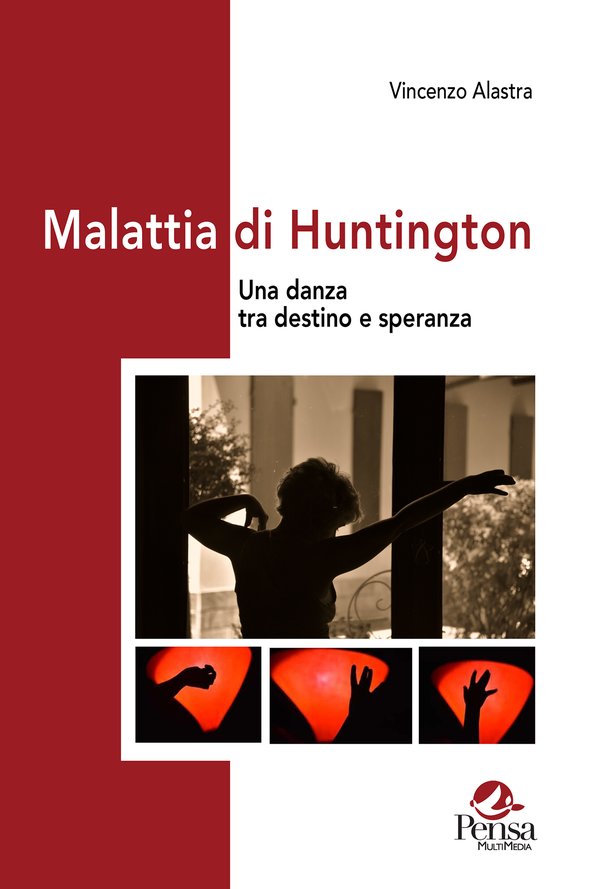 Vincenzo Alastra
Vincenzo Alastra
Malattia di Huntington. Una danza tra destino e speranza
Pensa Multimedia, Lecce 2024, p.228, 20€
L’autore del testo, Vincenzo Alastra, da anni si occupa di relazioni di cura, di medicina centrata sul paziente e di medicina narrativa. Questo libro è parte del progetto realizzato dall’Associazione Italiana Huntington Emilia Romagna, che si propone di dare alle persone colpite dalla malattia di Huntington la possibilità di «esprimersi, di rielaborare e condividere la propria esperienza, ma anche di unire le loro voci e intraprendere azioni diverse volte a sensibilizzare la cittadinanza sui problemi, sui bisogni e sui desideri connessi a questa malattia».
Persone malate, familiari e caregiver sono stati dapprima invitati a parlare delle proprie esperienze in interviste di tipo narrativo autobiografico e in seguito sono stati attivati in gruppi laboratoriali per percorsi di condivisione e di elaborazione creativa.
«La ricchezza del “materiale narrativo” complessivamente emerso è stata tale da spronare la pubblicazione di questo libro, in piena risonanza con la motivazione più profonda che ha fatto crescere il Progetto; vale a dire con la volontà (molto prossima a una necessità) di abbattere la disinformazione e quella morsa di solitudine che spesso circondano le persone malate di Huntington e i loro familiari».
Le testimonianze delle diverse figure coinvolte nelle interviste e nei laboratori e le riflessioni dell’autore del testo e dei suoi collaboratori portano chi legge a comprendere le tematiche relative alla sintomatologia nei diversi aspetti patologici, psicologici e sociali.
Quella di Huntington è una grave malattia neurodegenerativa trasmissibile in linea ereditaria, per la quale ancora non esiste una cura. Essa presenta sintomi, via via più gravi, che riguardano l’ambito neurologico (movimenti involontari, andatura irregolare, mancanza di equilibrio), l’ambito psichiatrico (depressione, tendenza al suicidio) e l’ambito cognitivo (calo delle prestazioni intellettive fino a una situazione di vera e propria demenza).
L’evoluzione della patologia è diversa da individuo a individuo, ma la perdita progressiva di autonomia fisica e mentale porta sempre, comunque, la persona a problemi che modificano radicalmente la sua vita sociale. Diventa necessaria la rinuncia ad attività lavorative e si modificano notevolmente le relazioni. Cambiano i rapporti amicali e si modificano i ruoli interni alla famiglia.
«Per la persona malata e gli altri componenti della famiglia, la malattia ha un portato esistenziale che può dirsi estremo e disperante: senza guarigione possibile, con il rischio (a volte la certezza) che la malattia continuerà a colpire altri familiari».
Di fronte alla definizione della diagnosi si presentano reazioni diverse, che riguardano sia il diretto interessato sia chi gli sta intorno: si possono osservare negazioni, fughe, sottovalutazioni, senso di sopraffazione emotiva.
Parimenti i sentimenti di inadeguatezza e di vergogna, legati ai sintomi che si presentano con l’evolversi della patologia, e le conseguenti condizioni di isolamento sociale non riguardano solo coloro che sono affetti dalla malattia, ma anche i loro familiari.
Nel passato si parlava di questo morbo come del Ballo di San Vito e veniva associato a possessione demoniaca. Ora i fenomeni con cui si manifesta, principalmente i disturbi motori, possono far pensare a peculiarità comportamentali di alcolisti, tossicodipendenti o psicopatici gravi, persone vissute come inquietanti e/o pericolose. Permane quindi nelle famiglie il sentimento di vergogna e la tendenza a non esporre il proprio caro allo sguardo derisorio o intimorito degli altri.
Lo stigma legato alla malattia di Huntington può essere superato con la conoscenza a livello sociale della patologia e dei sintomi ad essa associati. E tale è la finalità della pubblicazione di questo testo.
Margherita Mainini
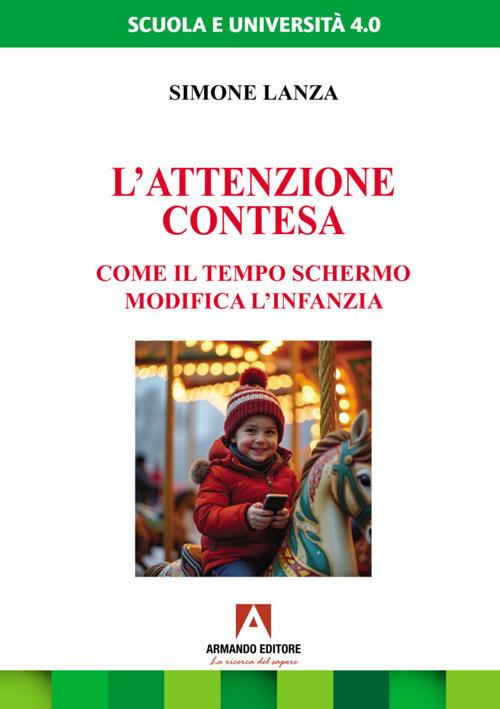 Simone Lanza
Simone Lanza
L’attenzione contesa. Come il tempo schermo modifica l’infanzia
Armando Editore, Roma 2025, pp. 226, € 19
Per recensire questo testo può essere utile partire dalla scelta del titolo e del sottotitolo. I tre sostantivi definiscono gli argomenti del saggio: l’attenzione, il tempo schermo e l’infanzia. L’aggettivo e il verbo, dal canto loro, rappresentano una dichiarazione di metodo e un posizionamento etico. L’attenzione agli effetti del tempo schermo, alla modifica che esso produce nell’esperienza infantile, è infatti letta come una forma di trasformazione dei suoi caratteri antropologici, per quanto stratificati rispetto a dimensioni come l’appartenenza di classe. Il termine contesa, infine, ci trasporta su un piano che – negli ultimi anni – è stato in gran parte espunto dal dibattito e dalla ricerca educativa: il fatto che chi educa, muovendo da una posizione di carattere democratico e progressivo, si trova a fronteggiare delle forme di educazione che si contrappongono – ahinoi, spesso con successo – a valori connessi alla condivisione, alla solidarietà, alla relazionalità e all’emancipazione. Ciò significa, inevitabilmente, che nessuna neutralità è possibile di fronte all’educazione informale: o si sceglie di sostenere lo spirito del tempo, ratificando e teorizzando a posteriori la bontà dello stato di cose presenti, o ci si pone in posizione critica rispetto all’esistente.
È di questa contesa, di un conflitto con finalità pedagogiche (spesso implicite) che parla il documentato e approfondito volume di Simone Lanza. Quella tra la pervasività del tempo schermo e le altre temporalità (sonno, relazione con i genitori e i coetanei, aria aperta, gioco libero, lettura…); quella tra l’accelerazione sociale, amplificata e sostenuta dalle tecnologie, e la capacità di aspirare a un futuro diverso e a essere in grado di connettere e raccontare le esperienze. Ma, soprattutto, quella inerente all’attenzione che gli schermi catturano e disgregano, sottraendola ad altri tipi di attenzione: quella congiunta attraverso la quale si impara a sintonizzarsi con la figura genitoriale di riferimento nella primissima infanzia, e tramite la quale si gettano le fondamenta della costruzione del linguaggio, oppure quella profonda che permette di acquisire una serie di conoscenze, competenze e abilità psicomotorie e comunicative fondamentali.
Un quadro inquietante, quello che emerge dalle pagine del testo, il quale illustra non soltanto «un deficit di apprendimento da schermo causato da una deprivazione educativa della mediazione umana», ma anche l’inserirsi di questo insieme di dispositivi in una pedagogia del consumo che, in quanto tale, mira a fidelizzare il più possibile i soggetti lasciandoli perennemente insoddisfatti, appiattendo la loro capacità di disancorarsi dalle proprie pervasive maglie. Nel fare ciò, tuttavia, l’età infantile risulta in pericolo, poiché sempre più adultizzata (come soggetto-consumatore) in un contesto di infantilizzazione dell’adultità ed espropriata delle sue peculiarità faticosamente costruite dalle spinte democratiche della modernità.
L’attenzione contesa, in conclusione, rappresenta il tentativo di connettere lo studio e il rigore analitico con la presa di posizione di fronte alle tematiche affrontate, risultando una lettura adatta tanto ad accademici e professionisti dell’educazione, quanto alle famiglie che desiderano approfondire una serie di dimensioni inerenti all’esperienza infantile. Il testo, infatti, invita a riflettere criticamente sugli effetti del tempo schermo, fornendo al contempo alcuni consigli rispetto a questa temporalità (in termini di età anagrafica, di quantitativo complessivo, di modalità e di contesto socio-relazionale, di organizzazione giornaliera e settimanale, e così via). L’invito, in estrema sintesi, è quello di «favorire l’attenzione anziché attirarla», non inseguendo sul suo stesso terreno un inafferrabile avversario, bensì prendendosi il tempo (o perdendolo, in ottica di consumo) per educare all’attenzione attraverso la relazione.
Simone Romeo

