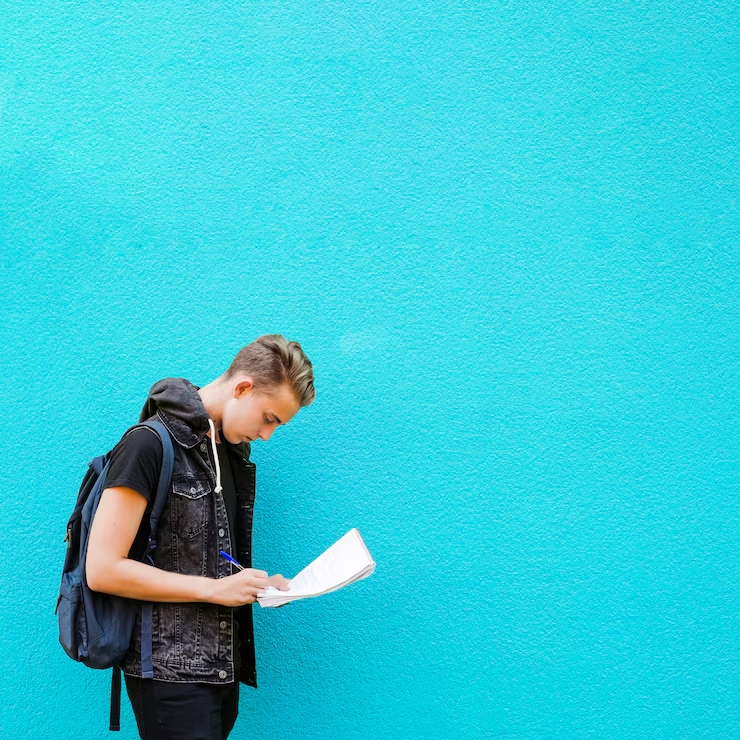Intervenire sulla dispersione scolastica
Situazione in Italia
La dispersione scolastica rappresenta un fenomeno complesso e multifattoriale, difficile da contrastare in modo univoco. Molti giovani abbandonano la scuola perché si sentono isolati, non compresi o sopraffatti dalle difficoltà che incontrano nel loro percorso. In questo contesto, il rafforzamento del supporto psicologico e sociale può fare una grande differenza: un consiglio tempestivo, un aiuto concreto nel superare un ostacolo, possono davvero cambiare il corso della vita di un giovane.
Preoccupante è il tasso di abbandono scolastico in Italia. È vero che sta diminuendo, avvicinandosi progressivamente alla media dell’Unione Europea, ma rimane comunque un dato preoccupante su cui serve intervenire tempestivamente per evitare il peggio. Nel 2023, la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano precocemente l’istruzione e la formazione è scesa al 10,5%, registrando una riduzione rispetto all’11,5% dell’anno precedente[1]. Negli ultimi dieci anni, si è osservata una costante diminuzione di questa percentuale e una progressiva riduzione del divario rispetto alla media europea, come evidenziato nei dati.
Nonostante questa tendenza positiva, il tasso attuale rimane superiore alla media UE del 9,5% e non ancora in linea con l’obiettivo comunitario di ridurre il tasso sotto il 9% entro il 2030.
Inoltre, si rileva una disparità di genere, con i ragazzi che presentano una probabilità maggiore di abbandonare la scuola rispetto alle ragazze (13,6% contro 9,1%). In Italia, il divario di genere è superiore alla media europea, con una differenza di 4,5 punti percentuali, rispetto ai 3,1 punti percentuali della media UE.
Un altro dato rilevante riguarda i giovani non nati in Italia, per i quali il tasso di abbandono scolastico è superiore al 25,5%, quasi triplicando quello dei giovani nati in Italia (9,1%) e significativamente al di sopra della media UE del 21,3%. Parallelamente, la “dispersione implicita”, che indica la percentuale di studenti che completano il ciclo di istruzione secondaria superiore senza conseguire gli obiettivi di apprendimento previsti, è scesa al 6,6%, con picchi superiori al 10% solo in due regioni, la Campania (15,7%) e la Sardegna (11,3%). Questo rappresenta il valore più basso dal 2019, anno di avvio della raccolta dei dati.
Se queste tendenze positive continueranno, l’Italia sarà sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo dell’Unione Europea di un tasso di abbandono scolastico inferiore al 9% entro il 2030 (INVALSI, 2024)[2].
Il PNRR riconosce la criticità della povertà educativa e destina risorse alla coesione territoriale. Tuttavia, per essere efficaci, gli interventi devono tradursi in azioni concrete e durature, costruite in rete tra scuola, servizi sociali, famiglie e comunità. Contrastare la povertà educativa deve essere parte di una strategia educativa integrata e partecipata, non un’azione isolata[3].
La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che include problemi come l’abbandono, l’assenteismo, le ripetenze, le bocciature, l’interruzione della frequenza, il ritardo nel percorso di studi e l’evasione scolastica. La ricerca scientifica identifica diversi fattori che contribuiscono alla dispersione, tra cui aspetti individuali, familiari, economico-sociali e scolastici[4].
Legame tra la famiglia e la dispersione scolastica.
La letteratura ha messo in evidenza, il legame tra la dispersione scolastica e le famiglie svantaggiate[5]. Il rapporto tra famiglia e scuola è cruciale in sociologia dell’educazione, poiché le condizioni materiali della vita familiare influenzano significativamente il successo scolastico dei bambini. Oltre agli aspetti simbolici e culturali, è fondamentale considerare le difficoltà materiali che le famiglie affrontano. Le famiglie in difficoltà economiche, infatti, spesso non riescono a creare un ambiente adatto allo studio, a causa di fattori come sovraffollamento, mancanza di risorse e scarso supporto emotivo e intellettuale. Questi ostacoli minano la concentrazione e l’apprendimento dei bambini, mentre le preoccupazioni quotidiane legate alla sopravvivenza impediscono lo sviluppo delle condizioni mentali necessarie per un apprendimento efficace[6].
Oltre agli aspetti materiali, anche l’accesso alle risorse culturali ed educative familiari incide sul successo scolastico. Secondo Bourdieu, il “capitale culturale” delle famiglie, come il livello d’istruzione dei genitori e la capacità di stimolare l’apprendimento, è fondamentale: chi ne possiede di più può sostenere meglio i figli negli studi, mentre chi ne ha meno rischia di limitarne le opportunità scolastiche[7].
Infine, gli squilibri familiari, come separazioni, lutti, disoccupazione o emigrazione, che non appartengono al singolo soggetto, ma che hanno presa sul bambino o bambina influenzandone le possibilità di azione, di pensiero, di autocomprensione, di relazione[8], rappresentano altri fattori che aggravano la situazione. L’abbandono scolastico precoce non è solo un segnale di disagio individuale, ma riflette anche le difficoltà di un sistema educativo nel garantire inclusione ed equità. Questo fenomeno causa problemi emotivi e psicologici nei bambini, influenzando negativamente il loro approccio alla scuola. Inoltre, la carenza di supporto affettivo e sociale aumenta il divario tra famiglia e scuola, peggiorando ulteriormente la situazione.
In modo simile, altri studiosi hanno sottolineato l’esistenza di una forte correlazione tra lo status familiare e il successo formativo dei giovani[9], un punto che è stato ulteriormente approfondito dagli studiosi, i quali hanno evidenziato il rapporto tra lo stile educativo dei genitori[10], il sostegno affettivo[11] e il fenomeno della dispersione scolastica. Inoltre, esistono studi che hanno identificato una connessione tra il basso livello di istruzione dei genitori e la tendenza alla dispersione scolastica [12], così come tra il reddito familiare[13], l’appartenenza a minoranze etniche[14] e la dispersione. Tuttavia, non è corretto interpretare un singolo fattore isolatamente[15]. Infatti, alcuni giovani, pur essendo cresciuti in contesti familiari disfunzionali o economicamente e culturalmente svantaggiati, sono riusciti a completare con successo il loro percorso scolastico. Questo evidenzia la necessità di una visione più complessa e integrata dei fattori che influenzano la dispersione scolastica.
Non sempre sono gli stili parentali e le pratiche educative troppo permissive a causare l’alienazione e la dispersione scolastica nei giovani; talvolta, anche stili genitoriali troppo rigidi e autoritari possono contribuire a questo fenomeno. La famiglia, quindi, può essere vista come un fattore di rischio, ma allo stesso tempo può svolgere anche un ruolo protettivo nei confronti della dispersione scolastica[16].
Questo evidenzia l’importanza di un equilibrio nelle pratiche educative familiari, che favoriscano il benessere e la partecipazione attiva del giovane a scuola. Un adeguato supporto emotivo e educativo da parte della famiglia è fondamentale per prevenire fenomeni come l’analfabetismo emotivo.
Analfabetismo emozionale e l’impatto sulla dispersione scolastica
L’analfabetismo emozionale[17], è un fenomeno che contribuisce in modo significativo a diversi comportamenti problematici tra i giovani, come chiusura in sé stessi, ansia, depressione, difficoltà di attenzione, aggressività, delinquenza e, in ultima analisi, abbandono scolastico. I ragazzi che subiscono il rifiuto sociale, in particolare quelli più timidi o più aggressivi, spesso presentano una bassa capacità di riconoscere e comprendere i segnali emozionali e sociali, possedendo un repertorio limitato di risposte comportamentali. Tali giovani sono a rischio di abbandono scolastico da due a otto volte maggiore rispetto ai loro coetanei che hanno una rete di amici[18]. Questo sottolinea l’importanza di un intervento che sviluppi l’intelligenza emotiva nei ragazzi. I genitori, infatti, hanno un ruolo fondamentale nell’educare i figli a gestire le proprie emozioni, insegnando loro che la felicità e l’infelicità non dipendono dagli altri, ma dalla capacità di riconoscere e valorizzare le proprie risorse interne, così da poter realizzare il proprio destino[19]. L’intelligenza emotiva, secondo Daniel Goleman, è la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. È fondamentale per agire in modo appropriato nelle diverse situazioni della vita ed è spesso più importante dell’intelligenza cognitiva, influenzando benessere, relazioni e successo personale e professionale[20].
La dispersione e l’abbandono scolastico sono fenomeni complessi influenzati da fattori individuali, educativi e socioeconomici. Tra i principali elementi di rischio nel contesto familiare ci sono basse aspettative dei genitori, povertà culturale, basso livello d’istruzione e un ambiente affettivo inadeguato. Le aspettative genitoriali, in particolare, possono influenzare significativamente il rendimento scolastico dei figli, come evidenziato dall’effetto Pigmalione[21]. Le aspettative dei genitori influenzano profondamente la motivazione e il rendimento scolastico dei figli. Aspettative basse e giudizi negativi, come etichettarli come “svogliati” o “poco intelligenti”, possono portare i ragazzi a credere di non poter migliorare, rafforzando un senso di fallimento. Inoltre, il livello di padronanza linguistica è cruciale per l’apprendimento: secondo Vygotskij, il linguaggio è lo strumento fondamentale per lo sviluppo del pensiero e dei processi cognitivi[22].Un contesto familiare privo di risorse linguistiche, educative o progettuali può compromettere lo sviluppo personale e intellettivo degli studenti. Condizioni come precarietà abitativa, disoccupazione e assenza di modelli positivi possono causare insicurezza, bassa autostima e disinteresse verso la scuola, spingendo i ragazzi a sentirsi inadeguati e a allontanarsi dall’educazione. Il lavoro pedagogico mira a comprendere le cause di tali situazioni e a sviluppare strategie efficaci per affrontarle, coinvolgendo le persone interessate[23]. L’approccio pedagogico permette di riflettere sull’influenza che le condizioni affettive hanno sulle azioni quotidiane dell’individuo, così come sulle esperienze e gli stili di vita che vengono messi in atto in risposta a tali condizioni. Si tratta, quindi, di uno sguardo attento a come il disagio contribuisca a educare chi lo vive, influenzando il modo in cui queste persone fanno esperienza del mondo e gli attribuiscono significato.
Affettività ed apprendimento
Le emozioni rivestono un’importanza fondamentale nel processo educativo. Il “filo che li unisce” è la capacità di creare un contesto di apprendimento che promuova il benessere emotivo degli studenti, in quanto un ambiente affettivo favorevole può significativamente potenziare la qualità del processo di apprendimento.
Un modello interessante per comprendere le connessioni tra demotivazione scolastica, bassa autostima e difficoltà di apprendimento è quello proposto da Borkowski, Carr, Rellinger e Pressley. Secondo questi autori, gli studenti che vivono difficoltà di tipo emotivo-relazionale tendono a sperimentare numerosi fallimenti nelle loro interazioni scolastiche e sociali. Queste esperienze negative possono portare allo sviluppo di due atteggiamenti opposti, entrambi disfunzionali: da un lato, un senso di impotenza appresa, che induce il ragazzo a sentirsi incapace di affrontare le situazioni; dall’altro, una percezione irrealistica di onnipotenza, che lo porta a sopravvalutare le proprie capacità. In entrambi i casi, si osserva una scarsa propensione a riflettere sui risultati delle proprie azioni e ad attivare processi di autocorrezione[24]. Questo blocco nella consapevolezza e nella gestione del proprio apprendimento può favorire il disimpegno progressivo dallo studio e dalla vita scolastica, fino a sfociare, nei casi più gravi, nella dispersione scolastica vera e propria.
La relazione tra affettività e apprendimento suggerisce che una scuola che non affronta adeguatamente gli aspetti emotivi degli studenti, concentrandosi solo sulla trasmissione di contenuti teorici, non promuove né l’apprendimento né il benessere. Quando le difficoltà emotive, sociali o scolastiche non vengono supportate, il sistema educativo fallisce nel prevenire l’abbandono scolastico. L’assenza di supporto psicologico e sociale rende difficile contrastare la dispersione scolastica[25]. In questo contesto, è necessario un intervento sistematico che integri il supporto affettivo e psicologico all’interno dei processi educativi, al fine di creare un ambiente scolastico inclusivo e accogliente, capace di promuovere il benessere emotivo degli studenti e, di conseguenza, di favorire il loro successo educativo.
Oggi, per coinvolgere attivamente i genitori nel percorso scolastico dei figli, è fondamentale affrontare temi concreti e rilevanti, che siano legati non solo alla crescita dei ragazzi, ma anche ai ritmi quotidiani dell’apprendimento e dello sviluppo della loro personalità. Questo implica l’importanza di una presenza attiva delle famiglie nella vita scolastica, che vada oltre le associazioni ufficiali e comprenda anche i gruppi informali di genitori[26].
Per contrastare la dispersione scolastica, è fondamentale creare una rete di supporto che coinvolga scuola, famiglie e comunità, affrontando le difficoltà emotive, sociali e scolastiche degli studenti. La scuola deve essere inclusiva e sensibile ai bisogni emotivi, con le famiglie che devono partecipare attivamente al percorso educativo. Una stretta collaborazione tra tutti gli attori è essenziale per garantire un’educazione solida e opportunità per il futuro. L’intervento pedagogico aiuta a rielaborare il disagio e a sviluppare strategie per affrontare difficoltà, demotivazione e rischio di abbandono, favorendo cambiamenti significativi nella crescita degli studenti e nel miglioramento dei servizi educativi.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
[1]https://ec.europa.eu/.
[2] https://op.europa.eu/
[3] https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2022-06/dispersione-scolastica-2022.pdf
[4] M. Janosz. L’abandon scolaire chez les adolescents: Perspectives nord-américaines. VEI Enjeux, 2000, 122, 105-127.
[5] D. Millet, D. Thin, Ruptures Scolaires: L’école à l’épreuve de la question sociale. Paris, PUF, 2005.
[6] P. Bourdieu. Meditazioni pascaliane. Campi del sapere Feltrinelli, 1998, p. 38.
[7] M. Pitzalis, A. Borghini, G. Pinna, E. Gremigni. BOURDIEU IN ITALIA Esperienze di una sociologia generativa. Pisa university press, 2024, p. 154.
[8] C. Palmieri. Crisi sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica. Franco Angeli, Milano, 2012, p. 26.
[9] J. S. Coleman. The adolescent society. New York, Free Press, 1961.
[10] S. Kakpo. Travail hors la classe: familles populaires, familles hyperpartenaires?.Diversité,Ville-École-Intégration,2009, 156, 98-103.
[11] P. Potvin, R. Deslandes, P. Beaulieu, D. Marcotte, L. Fortin, E. Royer, D. Leclerc. Risque d’abandon scolaire, style parental et participation parentale au suivi scolaire. Revue canadienne de l’éducation, 1999, 441-453.
[12] K. Lundetræ. Does parental educational level predict drop-out from upper secondary school for 16-to 24-year-olds when basic skills are accounted for? A cross country comparison. Scandinavian Journal of Educational Research, 2011.
[13] M. Lofstrom. Why Are Hispanic and African-American Dropout Rates So High? Williams Review, 2007, 2, 91-121.
[14]C. Blaya. Décrochages scolaires. L’école en difficulté. Bruxelles, De Boeck Supérieur, 2010.
[15] RW. Rumberger. Why Students Drop out of School and What Can Be Done. Paper preparato per la Conferenza, “Dropouts in America: How Severe is the Problem? What Do We Know about Intervention and Prevention?” Civil Rights Project, Cambridge, Massachusetts, Harvard University, 2001.
[16] R. D. Conger, K. J. Conger, M. J. Martin. Socioeconomic status, family processes, and individual development. Journal of Marriage and Family, 2010, 72, 685–704.
[17] D. Goleman. Intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici. Rizzoli, Milano, 1998.
[18] S. R. Asher, J.G. Parker, Significance of peer relationship problems in childhood, in Schneider, G. Attili, J. Nadel, R. P. Weissberg. Socil competence in developmental perspective, Kluwer Academic Published, London, 1989.
[19] M. Rosci. Genitori si diventa. Aiutare i figli a costruire la propria identità. Giunti, Firenze, 2007.
[20] D. Goleman, Intelligenza emotiva. Che cos’è e perché può renderci felici, Rizzoli, Milano, 2011.
[21] R. Rosenthal, L. Jacobson. Pigmalione in classe. Aspettative dell’insegnante e sviluppo intellettuale degli allievi. Franco Angeli, Milano, 1972.
[22] G. Perricone, C. Polizzi, M. R. Morales, A. Carollo, I. Rotolo e R. Caldarella, Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione con elementi di Psicologia pediatrica, Ed. aggiornata, Milano, 2018, 153 ss
[23] C. Palmieri. Crisi sociale e disagio educativo. Spunti di ricerca pedagogica. Franco Angeli, Milano, 2012, p. 32.
[24]C. Cornoldi. Difficoltà di apprendimento. Il Mulino, Bologna, pp. 253-271.
[25] F. Frabboni, M. Baldacci. Didattica e successo formativo: strategie per la prevenzione della dispersione scolastica, Vol. 12, Milano, Franco Angeli, 2004.
[26] L. Pati. Pedagogia Sociale. Temi e problemi. La Scuola, Brescia, 2022, p.105.