Fuga di cervelli – Come salviamo la cultura?
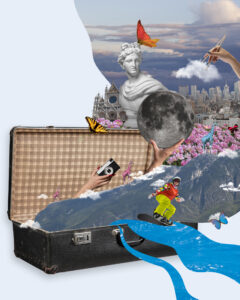 Oggi, 23 maggio 2025, si tiene a Bruxelles il Consiglio “Competitività”, durante il quale i ministri degli Stati membri dell’Unione Europea discutono il programma futuro in materia di ricerca e innovazione. Tra i temi all’ordine del giorno, spiccano la valutazione intermedia del programma Orizzonte Europa e l’agenda politica dello Spazio Europeo della Ricerca per il periodo 2025-2027. L’evento rappresenterà un’occasione decisiva per definire come e in che modo l’EU stanzierà il piano di attrazione dei ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo.
Oggi, 23 maggio 2025, si tiene a Bruxelles il Consiglio “Competitività”, durante il quale i ministri degli Stati membri dell’Unione Europea discutono il programma futuro in materia di ricerca e innovazione. Tra i temi all’ordine del giorno, spiccano la valutazione intermedia del programma Orizzonte Europa e l’agenda politica dello Spazio Europeo della Ricerca per il periodo 2025-2027. L’evento rappresenterà un’occasione decisiva per definire come e in che modo l’EU stanzierà il piano di attrazione dei ricercatori e scienziati provenienti da tutto il mondo.
Se si prova a “googlare” l’espressione “fuga di cervelli” nei più comuni motori di ricerca, ben si nota come il concetto venga quasi sempre associato all’emigrazione di studenti e professionisti italiani verso l’estero. Tuttavia, recentemente, si osserva un fenomeno inverso: un significativo numero di accademici, scienziati e storici statunitensi sta considerando l’Europa come nuova sede per proseguire le proprie attività. Secondo un sondaggio della rivista Nature[1], il 75% dei ricercatori interpellati ha dichiarato l’intenzione di lasciare gli Stati Uniti per continuare la propria carriera altrove.
Le cause di questa migrazione risiedono nelle politiche dell’amministrazione di Trump nei confronti delle università americane, caratterizzate da consistenti tagli alla ricerca. Si stima, infatti, che siano stati bloccati finanziamenti per circa 2,2 miliardi di dollari, con la conseguente sospensione di progetti dedicati soprattutto all’innovazione e alla lotta contro la crisi climatica.
Queste direttive hanno suscitato grande preoccupazione tra i presidenti delle maggiori università americane – tra cui Harvard, Columbia, Northwestern o Princeton – tanto che il presidente dell’università di Harvard Alan Garber ha dichiarato come «nessun governo, indipendentemente dal partito al potere, dovrebbe dettare cosa possono insegnare le università private».
In questo quadro, in Europa sembra scorgersi l’altra parte della medaglia. Moltissime nazioni come Germania, Francia e Norvegia, hanno lanciato appelli per accogliere ricercatori e accademici americani, offrendo loro asilo e opportunità. Durante la conferenza svolta a Parigi Choose Europe for Science, Macron ha sottolineato, a questo proposito, l’importanza di rendere l’Europa competitiva e attrattiva per i ricercatori statunitensi, promuovendo così una scienza libera e indipendente.
I tagli imposti del governo trumpiano, inoltre, avranno ripercussioni significative anche sull’occupazione. Ciò causerà un impoverimento non solo nel settore della ricerca, ma anche in quello medico, con potenziali conseguenze sulla salute pubblica.
Ora che il sogno americano sembra quindi vacillare, il resto del mondo si adopera per salvaguardare un patrimonio conoscitivo comune. Che l’Europa diventi davvero il nido di rinascita in grado di tutelare il sapere di un continente preda di misure ostili?
Intanto, in Italia, la ministra dell’università e della ricerca Anna Bernini, non ha presenziato all’evento di Parigi. Secondo fonti ministeriali, l’assenza potrebbe essere attribuita a un segno di protesta nei confronti del ruolo prevalente della Francia all’interno della conferenza, o alla poca tempestività nel cogliere questa grande opportunità.
La Bernini ha dichiarato che l’Italia ha già agito sui finanziamenti, ma in una nazione dove già la carriera di ricerca è precaria e spesso poco riconosciuta, quella di Parigi rappresentava un’altra occasione per rendere le università italiane il più possibile attrattive.
Intanto però, nel nostro Paese, dove sembra che tutti vogliano scappare, c’è invece chi arriva.
Ci sono, infatti, anche notizie incoraggianti[2]: sono in crescita, nelle Università e negli istituti di secondo grado, il numero di studenti stranieri che scelgono l’Italia per iniziare o completare il loro percorso di studi. Anche le conseguenze della Brexit si pongono come motivazione decisiva per spingere i giovani a lasciare il paese, e anche in questo caso, l’Europa ma anche l’Italia, sembrano le mete preferite. In un Europa in subbuglio per le nuove elezioni, ecco che anche il nostro Paese può riscattarsi come fucina di conoscenza. Può riaffermarsi, appunto, come un luogo in cui la libertà di pensiero è coltivata e diffusa: scegliendo una scienza indipendente e un clima culturale che accoglie e non respinge.
La speranza è che, in un mondo sempre più diviso e divisivo, la condivisione del sapere possa essere il collante per comprendere, orientarsi e unire. Se nessuna nazione da sola può fare ciò, ogni realtà può nella sua dimensione reagire a questa nuova onda creando le condizioni favorevoli e mettendo a disposizione risorse. Tutelare chi sceglie di crescere, studiare e insegnare in Italia significa quindi costruire basi più solide per una società che voglia davvero imparare, innovare e, soprattutto, restare libera.

