Considerazioni sulle teorie della mente
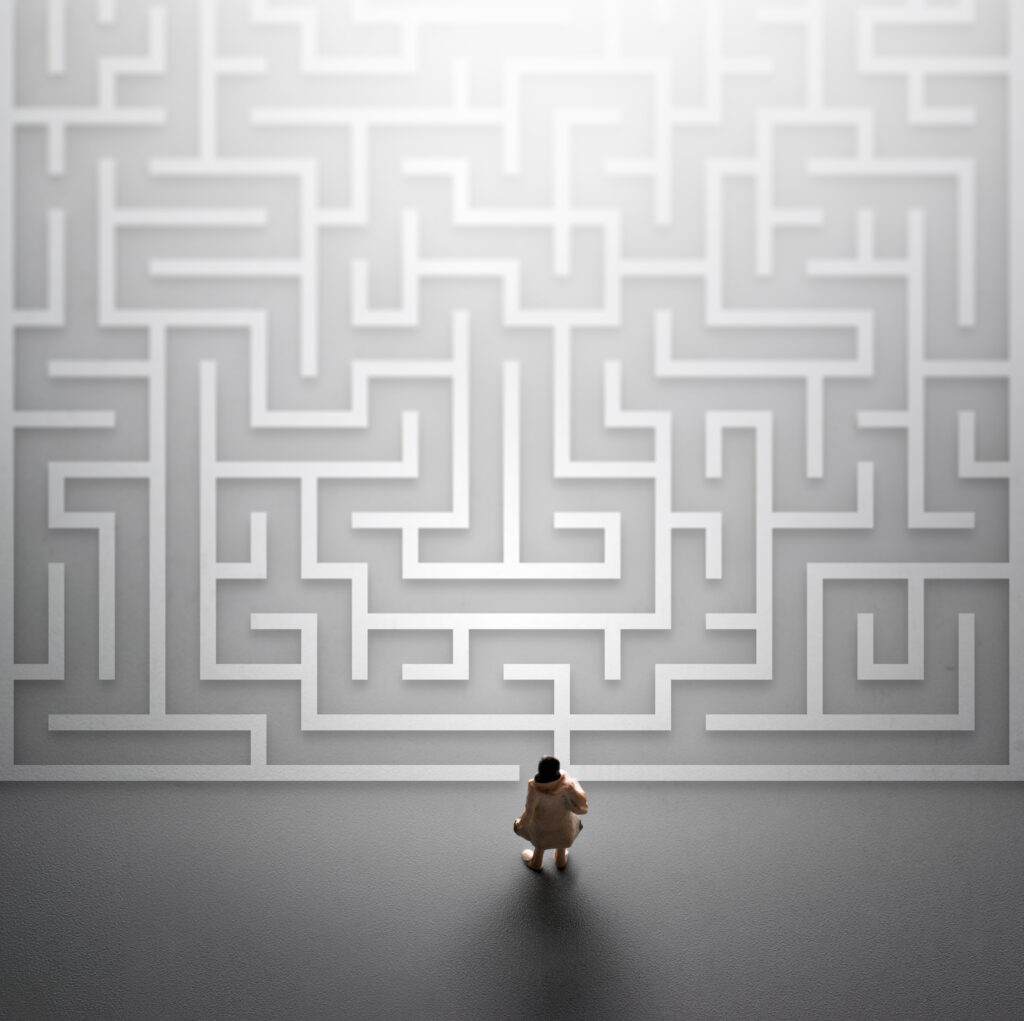 Di Pietro Sacchelli
Di Pietro Sacchelli
(Docente a contratto di Pedagogia Scolastica c/o l’Università di Roma Tre)
Alcuni anni fa, in un incontro on line con gli studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Parma, mi è stata rivolta la domanda cosa siano le teorie della mente e quale importanza rivestano nei processi di insegnamento-apprendimento. Pensai allora di introdurre la spiegazione ricorrendo a una nota barzelletta per rendere l’approccio all’argomento più naturale e disteso.
“In una clinica psichiatrica viene ricoverato un uomo affetto da una grave psicosi perché, convinto di essere un chicco di granturco, ha il terrore di essere mangiato dalle galline. Dopo una lunga degenza e quotidiane sedute psicoterapeutiche, il paziente sembra guarito e pronto per essere dimesso dalla struttura sanitaria. Nel colloquio finale lo psichiatra lo fissa negli occhi e gli chiede con voce ferma: “Allora Giuseppe, mi risponda in modo franco: se le chiedo chi è lei, cosa mi risponde?”
Sicuro di sé il paziente ribatte: “Adesso dottore so di essere un uomo e non più un chicco di granturco.”
Soddisfatto della risposta, il medico abbozza un sorriso e firma la lettera di dimissioni congedandosi da Giuseppe con una calorosa stretta di mano.
Mentre si avvia verso il cancello d’uscita, una gallina attraversa la strada davanti a lui. Di colpo l’uomo si ferma terrorizzato e, tornato indietro di corsa, entra trafelato nell’ambulatorio dello psichiatra nascondendosi sotto la scrivania urlando con aria sconvolta: “Scusi dottore, ma prima di uscire dal cancello una gallina ha attraversato il vialetto a due passi da me!”
Lo psichiatra lo guarda con aria confusa e replica:
“Giuseppe, poco fa mi ha detto di essere un uomo e non un chicco di granturco…”
“È vero dottore, sono consapevole di non essere un chicco di granturco, ma questo la gallina lo sa?”
La simpatica storiella sottolinea la difficoltà del protagonista di operare il decentramento cognitivo per mettersi nella disposizione mentale degli altri (mindreading), processo che attiene alla teoria della mente o mentalizzazione (mentalizing). Questa difficoltà, diffusa anche a scuola tra gli alunni con comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti dei compagni più deboli (fenomeno del bullismo) o nei soggetti autistici che evidenziano problemi nei rapporti sociali, è sintomo di un io “incistato” e privo di slanci empatici verso i propri simili. Essa connota dunque un ego autoreferenziale che impedisce di provare emozioni e solidarietà umana nei riguardi di chi soffre.
Breve excursus sulle teorie della mente
Prima degli anni Ottanta del secolo scorso in ambito psicosociale era diffusa la “teoria della teoria” o “theory-theory” secondo la quale l’essere umano utilizza modelli interni a carattere deduttivo per interagire con la realtà esterna. Il comportamento ad esempio di un bambino di un anno che allontana con la mano il cucchiaio della pappa o chiude la bocca voltandosi dall’altra parte induce la mamma a formulare alcune ipotesi verosimili per capire i motivi di rifiuto del cibo. Il piccolo non ha appetito perché ha mangiato troppo nel pasto precedente oppure si sente poco bene? Forse preferisce assaggiare qualcosa di diverso o si tratta semplicemente di un capriccio aggirabile con qualche coccola?
La madre verifica le sue ipotesi una alla volta ossia ricorre a schemi precostituiti per risolvere il problema. La vita sociale delle persone si basa su criteri di anticipazione mentale che consentono di adeguare i comportamenti a quelli altrui cercandone un’interpretazione razionale. In altre parole le azioni non sono mai neutrali perché vengono sempre e comunque interpretate dagli altri secondo modelli mentali predeterminati. È per questo motivo che Gregory Bateson e Paul Watzlawick, esponenti di spicco della Scuola di Palo Alto e propugnatori della pragmatica comunicativa, sostenevano che non si può non comunicare poiché qualsiasi atteggiamento intenzionale o no trasmette comunque agli altri un messaggio. La ragazza che non si presenta all’appuntamento con un giovane incontrato a una festa la sera prima gli comunica indirettamente di non essere interessata ad approfondire la sua conoscenza.
Negli anni Ottanta e Novanta questo modello teorico fu affiancato, senza sostituirlo, dalla “teoria della simulazione” secondo la quale non comprendiamo gli altri secondo schemi teorici interni ma ricorrendo alla riproduzione dei loro stati mentali cioè disponendoci nella posizione altrui per comprenderne i vissuti. Questo nuovo modello teorico si è diffuso dopo la pubblicazione nel 1974 dell’articolo “Cosa si prova ad essere un pipistrello?” del filosofo Thomas Nagel pubblicato sulla rivista “The Philosophical Rewiew”. Esso solleva il problema della coscienza dislocata, negata dal materialismo e dal fisicalismo filosofico. L’autore prende in esame i pipistrelli (mammiferi della famiglia dei microchirotteri) anziché le aquile, le sogliole o le api perché più si scende nella scala filogenetica più diventa difficile comprendere l’esperienza soggettiva degli altri viventi.
Nagel giunge alla conclusione che, a causa delle notevoli differenze strutturali e sensoriali tra i pipistrelli e gli esseri umani anche se appartenenti entrambi alla classe dei mammiferi, è impossibile capire cosa provino questi animali con abitudini notturne. L’essere umano non è capace di immedesimarsi nei microchirotteri e ogni tentativo per cercare di farlo è destinato all’insuccesso. Addirittura è molto problematico farsi anche una vaga idea di quale sia lo stato d’animo di un cieco e/o di un sordo dalla nascita oppure di un paraplegico affetto da paralisi cerebrale. La loro particolare condizione psico-fisica infatti esula dall’esperienza delle persone con organi sensoriali integri. Al riguardo Nagel sostiene che se degli alieni atterrassero sul nostro pianeta non riuscirebbero a capire cosa pensiamo o proviamo realmente noi terrestri poiché le loro diverse condizioni sensibili e cognitive glielo impedirebbero. Ma commetterebbero un grosso errore se ci classificassero come esseri privi di emozioni e razionalità solo per il fatto che presentiamo una natura diversa. Quando l’esperienza acquista un valore oggettivo, ossia diventa comune e condivisa, allora diviene possibile immedesimarsi negli altri per partecipare empaticamente ai loro diversi stati d’animo.
Alla fine degli anni Ottanta furono soprattutto le ricerche di Robert Gordon, Jane Heale e Alvin Goldman a consolidare la teoria della simulazione non solo in termini filosofici ma anche psicologici e neuroscientifici. Tempo fa, dopo aver perso i contatti con mio fratello in un grande e affollatissimo ospedale e non riuscendo a rintracciarlo telefonicamente perché il mio cellulare era scarico, mi sono messo ad aspettarlo fiducioso davanti al bar del nosocomio. Poiché egli era digiuno dal mattino per alcuni controlli sanitari ho pensato che avrebbe consumato una colazione prima di rimettersi in viaggio per tornare a casa. In altre parole ho supposto che sarebbe stato suo desiderio fare un piccolo spuntino dopo un’estenuante mattinata di controlli e visite mediche. Dopo un paio di ore di attesa, infatti, mi è transitato davanti così come avevo previsto. In quel contesto avevo applicato il modello della simulazione cercando di capire come lui si sarebbe comportato in quella situazione. Naturalmente questa teoria non è immune da errori che commettiamo quando non applichiamo i principi della cosiddetta “quarantena” ossia se ignoriamo certi fattori come l’attribuzione impropria ad altri delle nostre conoscenze e credenze, di certi stati emozionali e negli affrettati giudizi di valutazione.
Nel 1992, nel laboratorio di neurofisiologia dell’Università di Parma, il Prof. Giacomo Rizzolatti ha fatto la rivoluzionaria scoperta dei neuroni specchio (mirror neuron) esaminando le cellule dell’area premotoria di un macaco attivate dall’animale non solo durante l’esecuzione di azioni specifiche (come ad esempio sgranocchiare delle noccioline) ma anche quando le vedeva compiere dagli altri primati (compreso l’uomo) mentre facevano la stessa cosa. I neuroni specchio servirebbero quindi a comprendere il significato delle azioni altrui, a intuire le loro intenzioni per adottare strategie comportamentali funzionali alla relazione. Grazie a questa importante scoperta dell’area cerebrale premotoria si possono spiegare certi disturbi come l’alessitimia (incapacità di provare emozioni) e magari in futuro mettere a punto specifiche cure farmacologiche.
L’empatia è entrata così a far parte delle teorie della mente riuscendo ad interessare anche ambiti scientifici estranei alla neurofisiologia come la linguistica, la psicologia sociale, l’arte e le scienze umane in generale. I neuroni specchio non solo consentono di comprendere gli stati d’animo degli altri, i loro desideri, i sentimenti (amore, vergogna, ansia) e le emozioni (rabbia, paura, felicità, sorpresa), ma anche di spiegare il ruolo svolto dall’intenzionalità delle persone nella loro attività meccanico-motoria già teorizzata dallo psicologo statunitense Gibson negli anni Settanta con il termine di “affordance” (traducibile con “invito all’azione”). In altre parole la percezione degli oggetti non è passiva ma ci stimola a intervenire con scelte e atteggiamenti coerenti con lo stimolo ricevuto.
Tuttavia l’empatia è tutt’altro che un concetto univoco poiché esso rimanda a fenomeni mentali simili ma differenti tra loro come l’imitazione dei comportamenti, la condivisione delle emozioni, la teoria del contagio e della simpatia che sono alla base dei legami sociali.
Teoria della mente e didattica fenomenologica
La fenomenologia, fondata nel primo ventennio del secolo scorso da Husserl, descrive l’esperienza vissuta o incarnata (Erlebnis) ovvero cerca di comprendere il ruolo svolto dalla coscienza in ambito gnoseologico evitando affrettati e fuorvianti spiegazioni empiriche. La recente applicazione di questo approccio alla pedagogia ha dato luogo alla didattica fenomenologica particolarmente interessata al rapporto tra l’oggetto culturale e l’alunno mediante l’indagine introspettiva delle sue modalità di elaborazione delle conoscenze. Questa metodica sposta l’attenzione educativa dalla dimensione cognitiva dell’insegnamento a quella mentale dell’apprendimento. Mentre l’intervento tradizionale pone il suo focus sul curriculo e sulle materie di studio, la didattica fenomenologica, attraverso una specifica modalità dialogica con l’alunno, lo mette al centro del processo formativo rendendolo consapevole del proprio stile di apprendimento.
L’approccio fenomenologico può contribuire a rendere il docente più rispettoso della dimensione interiore degli studenti attualmente sacrificata sull’altare curriculare ed epistemologico. La scuola italiana quindi dovrebbe fare lo sforzo di introdurre tra le sue pratiche quotidiane i principi della fenomenologia per promuovere un apprendimento consapevole, il metodo di studio e la personalizzazione indispensabile per un’autentica inclusione scolastica di tutti gli alunni e in particolar modo di quelli più bisognosi e con maggiori difficoltà.[1]
[1] Sacchelli P. “Insegnare ad apprendere è più facile se… sai come fare!” Ed. Il Papavero (AV), 2025.

