Il pianeta latente (Cosimo Accoto)
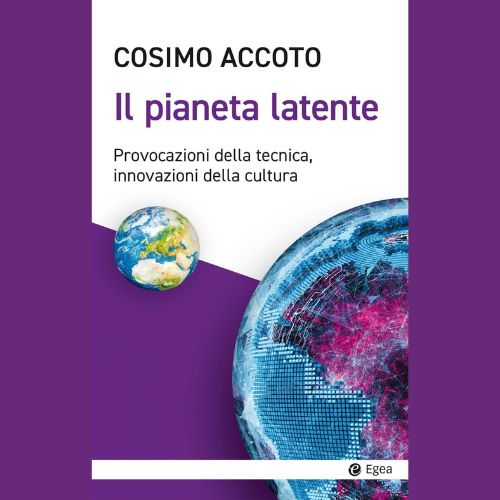 Cosimo Accoto
Cosimo Accoto
Il pianeta latente. Provocazioni della tecnica, innovazioni della cultura
Ed. Egea, Milano 2024
P. 127, € 18
Siamo abituati ad affrontare il tema controverso dell’AI con uno sguardo tecnico/strumentale oppure etico e in questi modi lo trasferiamo anche alle giovani generazioni nelle istituzioni scolastiche. Un po’ di algoritmi in più nelle discipline scientifiche, qualche raccomandazione sulla sicurezza dei dati e sulla possibilità di contenuti immorali con uno sguardo alla previdente legislazione UE. Per contrastare il possibile riduzionismo nella didattica e voler dare invece un respiro pedagogico al tema dell’AI ho trovato molto utile il testo di Cosimo Accoto, filosofo della tecnologia, ricercatore al MIT di Boston, che approfondisce le valenze culturali della trasformazione indotta dall’AI. L’autore auspica un cambiamento del senso e dei significati secondo i quali abbiamo finora interpretato la realtà dell’AI per accedere a una raffigurazione indotta dalle nuove ingegnerie che stanno costruendo il futuro di un pianeta sull’orlo di trasformazioni che riusciamo vedere ancora solo parzialmente, latenti appunto. Quello che Accoto ci presenta è un orizzonte esplorativo sulla AI generativa che si nutre di provocazioni intellettuali sulla evoluzione tecnico-automatica di azioni finora proprie dell’umano: la comunicazione, la visione e l’azione. E il tono provocatorio della riflessione dell’autore è finalizzato a far vacillare l’elementare certezza che basti garantire il controllo dell’umano sul tecnico per governare le innovazioni prodotte dalla AI. Ma le cose stanno diversamente se analizzate con sguardo filosofico. La prima provocazione che l’autore ci lancia riguarda la trasformazione della natura della parola da umana, portatrice di significati, a ingegneristica. La macchina che scrive è infatti un sequenziatore che data una frase incompleta è capace di predire la parola successiva sulla base di probabilità statistica. La conseguenza è che mentre il linguaggio umano ha un carattere espressivo-comunicativo quello elaborato dalle piattaforme di GenAi è un assemblaggio di dati a carattere operativo. Il linguaggio sintetico è senza significato, senza una esperienza di riferimento. L’assenza di un mondo che si conosce perché se ne fa esperienza attraverso il corpo è anche quella che, secondo l’autore, si riscontra nella produzione di immagini da parte dell’AI. L’immagine viene scomposta in pixel e a ogni pixel viene assegnato un valore numerico: è la griglia quantitativa, sulla quale si possono operare una serie di variazioni, che diventa la visione della macchina. Anche l’immagine, come già il linguaggio, diventa una creazione algoritmica, generando una visione senza uno sguardo. Quello che si va definendo nella trasformazione guidata dall’AI è un mondo ingegneristico che trasforma ogni attività in operazione. Fin qui i miei orizzonti di significazione traballano ma una ulteriore sfida è quella che l’autore fronteggia in merito alla capacità agentica dell’AI. Le grandi aziende stanno già introducendo gli agenti artificiali nei processi di gestione della qualità, della manutenzione e della logistica. Sono sistemi computazionali capaci di raccogliere informazioni, interagire con ambienti e sistemi esterni e eseguire attività e compiti assegnati. Per produrre le azioni il modello cognitivo della macchina, è quello della catena di pensieri, ossia uno spacchettamento ingegneristico del compito nelle fasi di un processo contraddistinto da una catena di input e output. Gli agenti possono agire da soli, in rete di diversi agenti o in coppie/gruppi misti di agenti e lavoratori/trici umani/e. Necessità, ne consegue, di un nuovo paradigma di organizzazione del lavoro e di concepire un nuovo sfidante sistema sociotecnico. Forse pensare all’ambito del lavoro, in cui sono più esperta, mi permette di cogliere la sfida impensata che le provocazioni dell’autore vogliono lanciare: il salto di paradigma culturale richiesto da una interpretazione non più umanocentrica delle intelligenze sintetiche. I nuovi attori ingegneristici sono qui per affiancarci in una creazione di nuovi significati capace di abbracciare la nuova, impensata convivenza.
Luisella Erlicher

