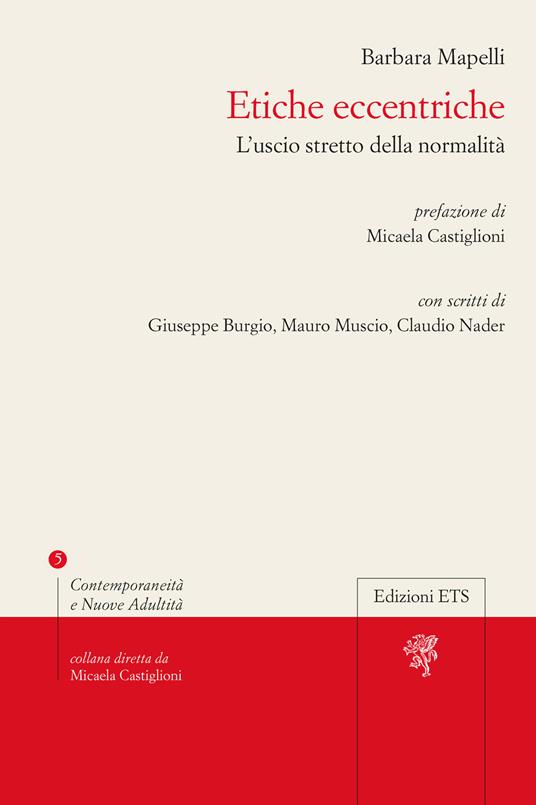“Etiche eccentriche. L’uscio stretto della normalità” (intervista a Barbara Mapelli)
Il nome di Barbara Mapelli è legato alle culture di genere fin dagli anni 70, quando l’attenzione a certe tematiche era ancora da conquistare: a livello formativo e scientifico il suo contributo su questi temi è stato fondamentale. Siamo amiche da molti anni e, insieme agli affetti di una vita, non abbiamo mai smesso di condividere tante idee, in particolare il bisogno (privato e pubblico) di narrare, piuttosto che definire. Non è tutt’oggi un obiettivo da poco.
Già? componente del Comitato Pari Opportunità? del Ministero Pubblica Istruzione e consulente presso il Ministero delle Pari Opportunità?, Barbara Mapelli ha insegnato Pedagogia delle differenze di genere (presso la Facoltà? di Scienze della Formazione dell’Università? di Milano Bicocca). Attualmente partecipa al Comitato Direttivo della Libera Università? delle Donne di Milano, oltre che ai comitati scientifici della Fondazione Giulia Cecchettin e della rivista Pedagogika. Infine, fa parte della redazione della rivista Leggendaria.
Autrice di numerosi volumi, contributi in testi collettivi, articoli su riviste specializzate e non, la pubblicazione più recente di B. Mapelli vuole essere, a mio avviso, una riflessione di tutto il suo percorso di studi. Lo stesso titolo – Etiche eccentriche. L’uscio stretto della normalità? (Edizioni ETS 2025) – evoca in effetti un certo paradosso: il linguaggio pedagogico, nella sua primaria valenza educativa, è capace di rendere fruibile a tutti il confine tra eccentricità e normalità? Da questa domanda, che nasce da continue esperienze nel merito, comincia la nostra conversazione con Barbara.
Perché “etiche eccentriche” in un mondo dove tutto sembra permesso e possibile? Perché, Barbara, è stretto l’uscio della normalità?
Quando si inizia a discutere di un libro, tanto più se è proprio chi lo ha scritto che ne parla, credo sia proprio utile avviarsi dal titolo, poiché esso – per ragioni più o meno nobili – è frutto di molto pensare, scegliere e riflettere per trovare da una parte una formula accattivante per aumentare le vendite (in accordo naturalmente con la casa editrice) e dall’altra una sintesi il più vicina possibile alle intenzioni e ai contenuti del volume stesso. Così è nato Etiche eccentriche. L’uscio stretto della normalità, che mi pareva potesse soddisfare ambedue le necessità – ma probabilmente di più la seconda.
Etiche eccentriche dunque: tu mi inviti a spiegarmi meglio poiché viviamo in una contemporaneità in cui sembra che ogni eccentricità sia possibile, ogni posizionamento morale sia lecito. Ed è proprio questo che io critico con la seconda parte del titolo, l’uscio…, perché questa libertà di essere, comportarsi – e certamente non sto dicendo nulla di nuovo – è apparente, illusoria, anestetizzante possibili scelte di essere e vivere che rappresentino l’autenticità di una persona.
La cosiddetta normalità, che ci viene fatta apparire come il naturale e giusto modo di stare al mondo mi appare come una serie perentoria di dover essere, di rappresentare copioni già scritti perché sei donna o uomo, perché sei bianco o nero, madre, nonna, single, ricca o povera. Siamo come su un palco a recitare battute che non abbiamo elaborato noi, ma che ci vengono suggerite o imposte per il corretto vivere nella realtà attuale. Anche l’eccentricità innocua, le trasgressioni che non nuocciono perché non mettono seriamente a critica le regole sono tollerate, anzi auspicate e messe in risalto perché aumentino l’impressione di libertà. Uscio stretto, dunque, nella seconda parte del titolo, e un richiamo all’invenzione e pratica di comportamenti etici che sappiano sfuggire alla morsa delle regole, dette e non dette, della società perbene.
Il femminismo italiano degli anni ’70 ha introdotto il metodo del “partire da sé”. Oggi è ancora così? È ancora vero che il meglio del femminismo resta nelle “storie personali”? Quali passaggi dei movimenti femministi ritieni abbiano inciso di più nel mettere in discussione l’idea di “normalità”? Ci sarebbe ancora bisogno oggi dello slogan sessantottino “Il personale è politico”?
Dedico a questo tutta la prima parte del volume, anche in tal caso adottando un aggettivo che accompagni nel modo più evocativo possibile, che resti cioè nella memoria di chi legge. Definisco infatti il femminismo come imperdonabile, poiché è stato, è, un movimento che riesce a vivere nella contemporaneità – e a porla a critica – ma senza appartenervi completamente, poiché vive su una soglia che prefigura, si propone un cambiamento radicale delle persone, delle modalità di relazione in ogni forma. Perché dunque ho citato la frase di Luisa Muraro, in cui lei afferma che il meglio del femminismo è dentro alle storie personali? Proprio perché ritengo che il metodo del ‘partire da sé’ sia ancora fortemente valido. La stessa risposta vale anche per l’altro importante slogan femminista ‘il personale è politico’. Si tratta di una metodologia di conoscenza e politica che mi appare tuttora l’unica che possa aiutare il rigore di un’interpretazione del reale e l’intento di trasformazioni radicali. Tutto ciò mi ha accompagnato in quel percorso di consapevolizzazione che ho avviato dagli anni Settanta: mi ha cambiato, mi ha aperto nuove prospettive, avviato a nuove percezioni del mondo e dei soggetti e di me nel mondo e in relazione con chi ha, e ha avuto, percorsi biografici differenti.
L’esperienza del partire da sé può essere letta come una pratica formativa, perché permette di comprendere la differenza non come limite ma come risorsa: quali strumenti educativi possono aiutare a trasmettere questa “pratica formativa”? Come cioè la scuola, l’università e gli ambiti formativi, possono valorizzare la cultura della diversità, portando a percorsi che abbiamo usci più generosi…?
La differenza non è mai un limite, ma una risorsa: non posso che essere d’accordo con te. Il discorso è lungo e complesso e l’affronto nel testo da molti punti di vista, ma certamente l’incontro con persone non binarie, che rifiutano l’eterosessualità e le definizioni vincolanti di genere ha insegnato a me, che appartengo alla cosiddetta normalità, quanto la stessa maggioranza di cui faccio parte rappresenti una parzialità, una possibilità come le altre di stare al mondo. Mi ha insegnato anche che si può cambiare o almeno trarre da vite differenti spunti e stimoli fondamentali per costruire insieme delle forme di etica non perentoria ma radicata nelle vite, nelle situazioni, nelle diverse culture. Quella che viene chiamata l’etica applicata.
Se dovessi indicare un’eredità viva del femminismo da consegnare oggi al discorso pedagogico, quale sarebbe, e in che forma può essere ancora trasformativa?
Se penso a quale sia per me la valenza educativa che gli insegnamenti del femminismo ci regalano, credo che la risposta migliore stia in quanto ho già detto: le pratiche del partire da sé e del personale – politico sono gli strumenti pedagogici che consentono, a partire dall’esperienza soggettiva, di leggere la realtà, interpretarla, trovare le strade per mutarla, riconoscendo in sé e nell’autenticità della ricerca personale anche il rigore morale per giudicarsi e giudicare.
E sono certa che tutto questo si possa insegnare.