Il mito di Sisifo e l’illusione di ingannare la morte
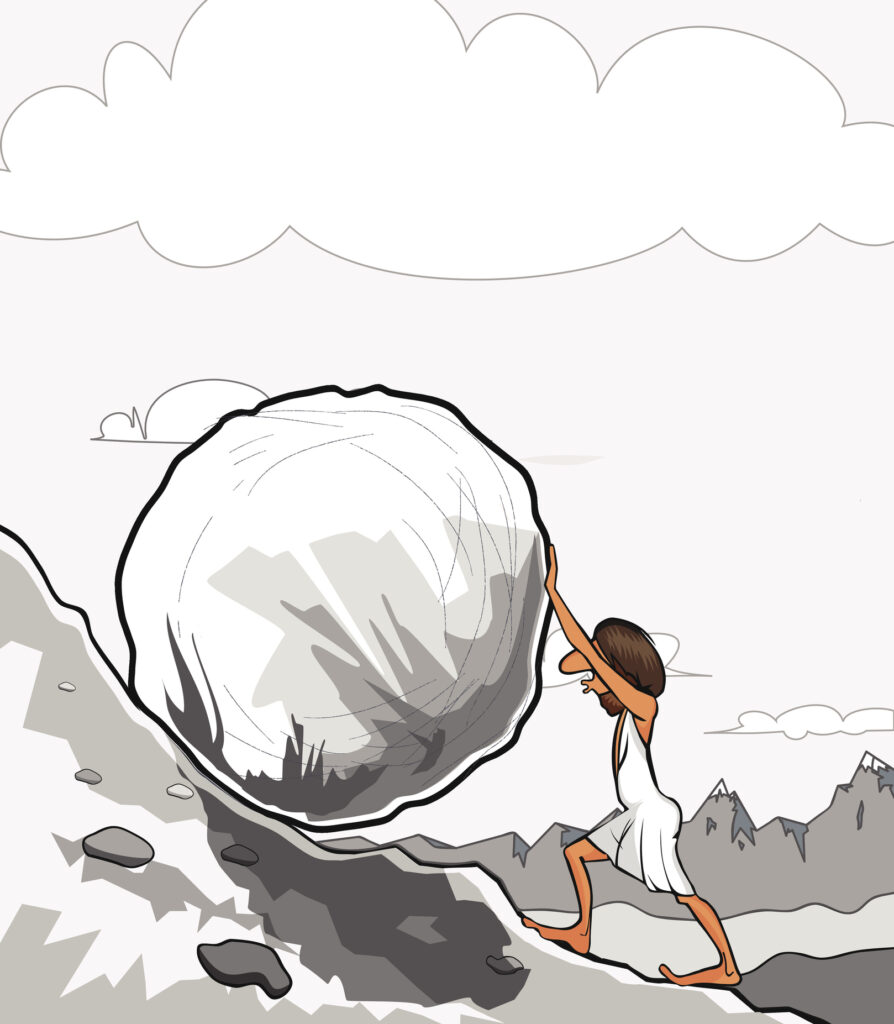 di Claudia Cacchioni
di Claudia Cacchioni
Psicologa, psicoterapeuta psicoanalitica, individuale e della coppia
Il mito di Sisifo, personaggio della mitologia greca, mette al centro il tema del rapporto dell’uomo con la divinità e con il tentativo di ingannare la morte, fantasia segreta e più o meno presente in ciascuno di noi.
La punizione che Sisifo riceverà per quanto commesso può assumere una duplice lettura: la vendetta di Zeus verso di lui per aver svelato il suo segreto, e un insegnamento a chi come Sisifo vorrebbe fermare il tempo. Se questo fosse possibile, condurrebbe a rimandare la realizzazione degli obiettivi: a vivere nella ripetizione senza riuscire a dare un senso alla vita che, per quanto possa apparire paradossale, acquista significato proprio per la sua finitezza.
Ma innanzitutto narriamo quale fu la storia di questo personaggio mitologico[1].
Sisifo e la rupe maligna
Figlio del dio dei venti Eolo e di Enarete, Sisifo aveva sposato Merope, una delle figlie di Atlante, ed era considerato il più astuto e avido tra gli uomini. A Corinto, dove regnava, ci fu una carenza d’acqua dovuta alla siccità e, mentre Sisifo era alla ricerca di una fonte, si era trovato a spiare Zeus che seduceva la ninfa Egina figlia del dio fluviale Asopo. Quest’ultimo, nella disperata ricerca di sua figlia, si era rivolto proprio a Sisifo, in quanto re. L’astuto re di Corinto aveva rivelato ad Asopo di aver visto sua figlia, ma senza dire con chi e che avrebbe potuto informarlo circa l’identità del rapitore solo se avesse accettato di dargli in cambio una fonte d’acqua dolce perenne. Pur di riabbracciare sua figlia, Asopo acconsentì al baratto: così il segreto di Zeus venne svelato e Sisifo ebbe la fonte Peirene. Adirato contro Sisifo per il misfatto, il dio dell’Olimpo chiese al fratello Ade di inviare a Corinto Thanatos, colui che simboleggiava la morte, per catturare il traditore ed esiliarlo negli inferi, tuttavia lo scaltro Sisifo adottò lo stratagemma di ubriacare Thanatos, legarlo e nasconderlo dentro una prigione segreta per diversi giorni. Ares, dio della guerra, si rese conto che durante le battaglie non moriva più nessuno perché la morte era scomparsa dal mondo, e così intervenne per liberare Thanatos e catturare Sisifo assolvendo in tal modo al volere divino.
Prima di sprofondare negli inferi, Sisifo si fece promettere dalla moglie Merope di non seppellire il suo corpo e nemmeno di celebrare il funerale. Tutto ciò faceva parte di un piano ben studiato: una volta morto, avrebbe protestato nei confronti degli dei in quanto senza sepoltura a causa dell’ingratitudine di sua moglie, e in questo modo avrebbe vagato in eterno lungo le rive dello Stige senza poter passare oltre. Fu così che, con la mediazione della dea Persefone moglie di Ade, Sisifo ottenne di tornare in vita ancora per qualche giorno, affinché Merope provvedesse allo svolgimento dei riti funebri dovuti. Ma il vero scopo di Sisifo era quello di tentare di sfuggire ancora una volta alla morte. Hermes – figlio di Zeus e guida delle anime dei morti all’inferno – riuscì a catturarlo e condurlo nell’Ade, dove il dio dell’Olimpo lo condannò ad un supplizio eterno che consisteva nello spingere un enorme masso da valle fino alla cima di un colle, ma una volta raggiunta la vetta il masso inesorabilmente tornava giù, costringendo il poveretto a ripetere l’impresa fallimentare per l’eternità.
Nel libro undici del poema omerico dedicato all’evocazione dei morti, Odisseo si reca nell’ Ade per consultare l’indovino Tiresia e sapere notizie sul suo viaggio di ritorno a Itaca e, per ottenere le informazioni necessarie, compie un rito di evocazione dei morti. Durante la discesa nell’Ade incontra diverse anime defunte tra cui quella di Sisifo. Così ricorda quell’apparizione:
Sisifo pure vidi, che pene atroci soffriva; una rupe gigante reggendo con
entrambe le braccia. E puntellandosi con le mani e coi piedi, la rupe in su
spingeva, sul colle: ma quando già stava per superare la cima, allora lo
travolgeva una forza violenta, di nuovo al piano rotolando cadeva la rupe
maligna. E lui a spingere ancora tenendosi: scorreva il sudore colando giù
dalle membra; intorno al capo saliva la polvere.[2]
Il mito di Sisifo alla luce della psicoanalisi
L’immagine evocata da Odisseo – Sisifo che raggiunge la collina, ma non riesce a fermare saldamente il masso sul terreno, che rotola giù all’infinito – rende l’idea della fatica e della frustrazione che egli prova a causa dall’inutilità dei suoi sforzi.
In psicoanalisi la tendenza alla ripetizione è stata concettualizzata da Freud (nello scritto del 1920, Al di là del principio di piacere) con il nome di coazione a ripetere. Quest’ultima è una tendenza inconscia a replicare comportamenti e situazioni dolorose o traumatiche, già sperimentate nel passato nonostante se ne comprenda razionalmente la dannosità. Queste precedenti esperienze negative, nel momento in cui si ripresentano, il soggetto le percepisce come subìte, perché non comprende come mai si trovi a commettere sempre gli stessi errori.
Si tratta di una ripetizione del passato attraverso un agire che non permette l’elaborazione dell’esperienza emotiva, processo che – invece – interromperebbe la catena ripetitiva. Secondo Freud la coazione a ripetere è una tendenza indipendente dal principio di piacere: per questo va al di là di esso (da qui il titolo del libro) e per questo Freud specifica che non tutto ciò che è ripetizione è coazione. «Questo eterno ritorno dell’uguale non ci stupisce molto se si tratta di un comportamento attivo del soggetto in questione e se in esso ravvisiamo una peculiarità permanente ed essenziale del suo carattere, la quale debba necessariamente esprimersi nella ripetizione delle stesse esperienze»[3].
A tal proposito Freud porta come esempio il gioco del bambino, dove la ripetizione di un’esperienza spiacevole assume caratteristica di elaborazione e controllo sulla realtà e non mera ripetizione: il bambino che viene visitato dal medico alla gola e prova fastidio o dolore, ripete infatti attivamente il giorno dopo la medesima esperienza durante il gioco, assumendo lui stesso il ruolo del medico mentre un compagno diventerà il paziente. Tale esperienza sarà trasformativa perché il bambino proverà piacere a cambiare ruolo, a far provare all’altro quanto ha provato lui; nello stesso tempo, familiarizzerà con questa esperienza e così, replicandola nella realtà, gli sembrerà meno spaventosa.
La coazione a ripetere può essere considerata anche da un vertice transgenerazionale, nel senso che i traumi, le esperienze negative, gli schemi comportamentali di tipo familiare vissuti da una generazione, possono essere trasmessi alle generazioni successive in modo inconsapevole.
Parlando di mito, basti pensare agli Atridi, la più tragica delle famiglie mitiche: Tantalo, Agamennone, Clitennestra, Elettra, Oreste ne fecero parte e le loro vicende sono state narrate nelle tragedie di Eschilo Sofocle e Euripide.
Se guardiamo poi alla punizione inflitta a tanti personaggi mitici, ci accorgiamo che essa è fondata sul concetto di colpa: nel caso di Sisifo, la sua colpa era stata quella di aver osato sfidare la divinità, portando alla luce quanto Zeus voleva restasse segreto; e di aver usato l’inganno per sfuggire alla morte.
In riferimento all’uso del mito in ambito clinico, si ritiene che sia di aiuto per il lavoro dello psicoanalista: sia nel caso in cui quest’ultimo riesca a rappresentarsi il contenuto di un mito, mentre il paziente descrive una situazione personale che lo affligge o lo irrita, o qualsiasi altra espressione emotiva; sia nel caso in cui lo psicoanalista, senza trasformare la seduta in una lezione di mitologia greca, si disponga ad aiutare il paziente affinché trovi, nel proprio racconto personale, elementi di un mito antico che potrebbe appartenergli.
Questo modo di procedere tenderà ad arricchire il dialogo analitico: aumentando la possibilità di rivivere ed elaborare situazioni dolorose, il paziente sarà facilitato nella possibilità di identificarsi e proiettare parti di sé in uno o più personaggi mitici. Nell’esempio di Sisifo il paziente, oltre a non sentirsi solo nell’affrontare la rupe maligna, con l’aiuto dell’analista pian piano riuscirà a dare senso alle proprie vicende e con il tempo modificare schemi comportamentali ripetitivi che lo renderanno capace di fare esperienze trasformative.
IMMAGINE: © iStock.com/Laco_Novotny
[1] Cfr. Kereny K., Gli dei e gli eroi della Grecia (vol. 2), Milano, Garzanti 1981(1958).
[2] Omero, Odissea testo a fronte, Torino, Einaudi tascabili 1989, p. 325.
[3] Freud S., Al di là del principio di piacere, vol. 9 (1917-1923), Torino, Boringhieri 1977, p. 208.

