Scelti per voi (Libri per tutti)
A cura di CLAUDIA ALEMANI
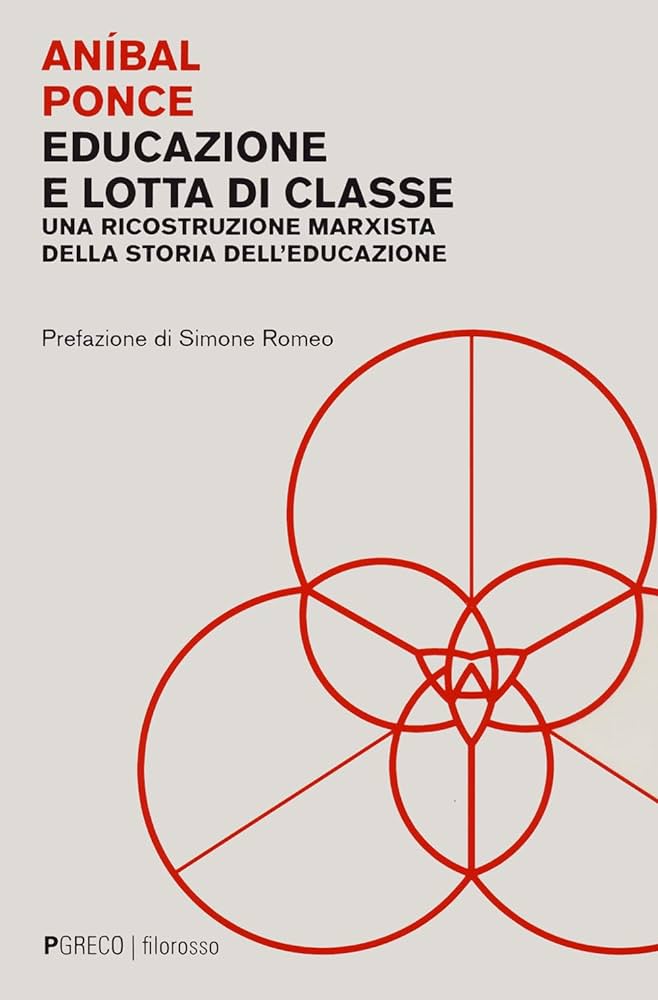 Anibal Ponce
Anibal Ponce
Educazione e lotta di classe. Una ricostruzione marxista della storia dell’educazione.
Prefazione di Simone Romeo
PGRECO Filorosso, Milano 2023, pp. 201, € 18
È stato recentemente (2023) rieditato dalle edizioni PGRECO il libro “Educazione e lotta di classe. Una ricostruzione marxista della storia dell’educazione” di Anìbal Ponce (1898-1938), pedagogista e filosofo sudamericano. Il libro è stato pubblicato in Argentina alla fine degli anni Trenta, in Italia alla fine degli anni Settanta, nel pieno di una stagione densa di conflitti e innovazioni sociali, politiche e culturali.
È un libro che potrebbe apparire antico. Antico perché scritto quasi un secolo fa, cioè in un tempo che appare lontanissimo, soprattutto oggi, in un presente in cui qualsiasi produzione scientifica e culturale sembra vivere l’espace d’un matin. Antico anche per i contenuti, non tanto per l’oggetto di analisi, l’educazione non può essere antica, è pratica sociale di ogni presente, quanto per lo sguardo con il quale l’oggetto è inquadrato e analizzato. Quello di Ponce è un libro scritto da un marxista che utilizza la chiave interpretativa della lotta di classe (qualcosa di molto diverso dall’intenzione di conferire dignità al punto di vista dei “poveri” per analizzare un contesto sociale), una chiave che oggi appare desueta, quasi un’intenzione di cui un po’ vergognarsi o un autocompiacimento minoritario. Ponce è antico anche nello stile: netto, deciso, “partigiano”, volutamente divisivo, molto lontano dalla ricerca di qualsivoglia ecumenismo, nulla a che vedere con cortesi dichiarazioni attorno alla ricerca di inclusività, lontano dalla promozione di discussioni che, quanto meno dichiaratamente, vogliono unire anziché dividere. Insomma, una vera boccata d’aria.
Il libro di Ponce afferma con chiarezza e decisione che l’educare non è neutro, non è un insieme di esperienze tutte tese al libero sviluppo di se stessi e degli altri che necessita solo di sufficiente convinzione e di una buona didattica per essere realizzato. L’educazione è stata ed è (non meccanicamente) determinata o influenzata dalle necessità riguardanti la divisione del lavoro, i ruoli sociali, i rapporti di potere, la condivisione per “forza o per amore” della cultura (mai omogenea) dominante o prevalente. L’educazione si trova a essere sempre e inevitabilmente schierata all’interno di qualsiasi assetto sociale, e in questo senso la pubblicazione del libro di Ponce è salutare perché invita, tenendo ovviamente presenti le differenze di tempi, luoghi e contesti, a leggerla, appunto, in questo modo, a soppesarla in relazione all’essere prodotta da, e produttrice di, dinamiche sociali. Il libro è una storia sociale dell’educazione (ma non può darsi altra storia dell’educare, ce l’ha mostrato Santoni Rugiu) che parte da quella nella “comunità primitiva” per arrivare alla “nuova educazione”. Ed è una storia raccontata con parole oggi quasi desuete (borghesia, piccola borghesia, proletariato; sfruttati e sfruttatori ecc.) per indicare concentrazioni di interessi conflittuali, ed è anche una storia nella quale i “mostri sacri” dell’educazione, da Rousseau a Montessori, per citarne solo alcuni, sono passati al vaglio “dell’analisi di classe”.
Quella di Ponce, come scrive nella prefazione Simone Romeo che ha curato la nuova edizione del libro, è «un’analisi che mostra il vincolo indissolubile tra i cambiamenti nell’organizzazione sociale della produzione e lo sviluppo di nuove teorie e sistemi educativi». Ed è una postura analitica che anche oggi esprime il suo funzionale valore utile a non perdersi nelle (finte) micronarrazioni attorno a una contemporaneità fatta tutta di flessibilità, fluidità, soggetti sociali che nascono e muoiono in un batter di ciglia. L’antichità di Ponce diventa allora attuale e necessaria, è una lettura, sempre nelle parole di Romeo, che invita «a essere sospettosi, anzi, a sottoporre a una serrata critica tanto le finalità educative, quanto le didattiche impegnate per raggiungerle». E questo diventa essenziale in tempi nei quali sembra che i conflitti in ambito educativo siano scomparsi e molte delle preoccupazioni siano quelle di adeguare obiettivi e metodi al presente del mercato.
Sergio Tramma
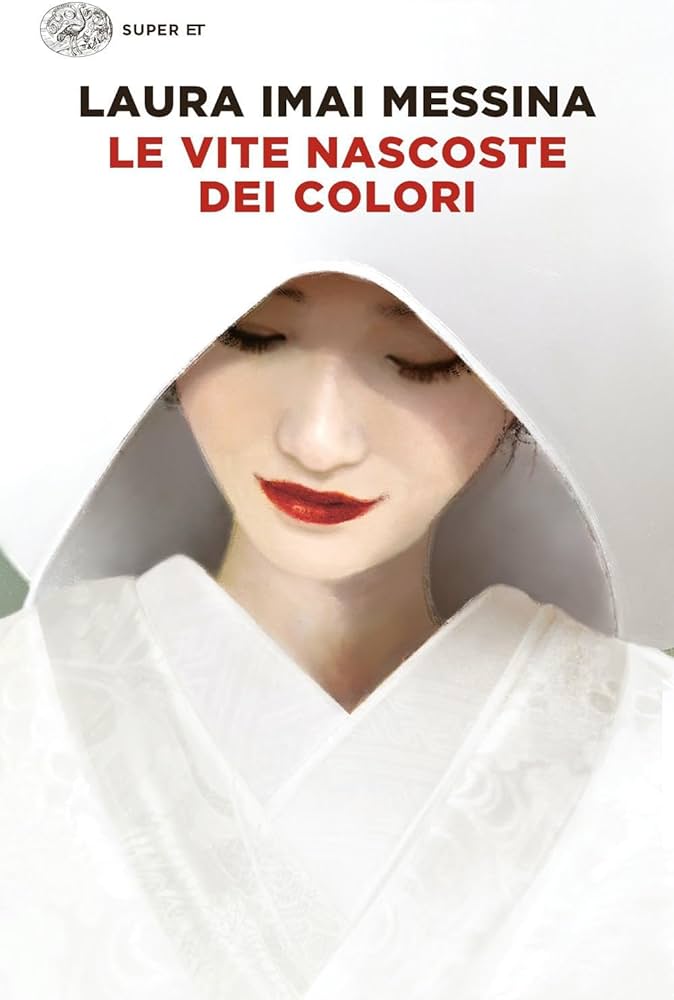 Laura Imai Messina
Laura Imai Messina
Le vite nascoste dei colori
Giulio Einaudi editore, Torino 2021, pp. 315, € 13,00
Grigio cenere e rosa ciliegio. Blu ripostiglio. Color sguardo furtivo a una brocca. Tre sfumature di colore per definire le tre tappe di una storia delicata ed avvincente che ci trasporta nel cuore di una cultura, quella giapponese, così lontana da noi, eppure così evocativa e ricca di suggestioni. Una cultura che Imai Messina ama e conosce molto bene, vivendo in Giappone da ormai molti anni.
Utilizzando un linguaggio che sembra cesellato da un pennello a punta fine capace di dare risalto ai minimi dettagli ed alle più svariate sfumature come in un acquarello delicato ed impalpabile, l’autrice ci conduce lentamente alla scoperta delle storie dei due protagonisti e delle loro famiglie, sullo sfondo di una Tokyo frenetica e contradditoria, in cui convivono modernità e tradizioni millenarie, in cui una profonda spiritualità si accompagna alla concretezza del vivere quotidiano.
Mio sa cogliere tutte le sfumature di colore, anche quelle invisibili ad un occhio normale. Cresciuta nell’atelier di famiglia dove, da generazioni, si creano i Kimono nuziali, shiromuku, tra tinte, pigmenti e tessuti preziosi, scopre la bellezza dei colori, e si costruisce un linguaggio tutto suo, strano e bizzarro, per definire e interpretare tutte le minime tonalità. Crescendo, i colori diventano il suo alfabeto, la sua bacchetta magica, il suo sguardo segreto sulla realtà e anche su ciò che è celato, tanto da riuscire ad attribuire ad ogni persona il suo colore più intimo, quella sfumatura particolare e unica che la contraddistingue.
Se per Mio il colore è equilibrio, precisione, sicurezza, tanto da «sprofondare nel bianco» quando le certezze crollano e la paura del dolore o della morte si manifestano, Aoi, il protagonista maschile, è daltonico, non vede i colori di Mio, ma conosce i gesti e i silenzi della cura. Nella agenzia famigliare di pompe funebri, gestisce con perizia e sapienza quel delicato momento di passaggio che è il funerale. Abituato, sin da piccolo, ad essere in contatto con la morte, non la teme, anzi ha imparato ad accettarla come parte integrante della vita ed ha sviluppato una grande capacità di ascoltare, di entrare in empatia con il dolore e le storie delle persone, di capirne le esigenze, di accompagnare chi se ne va e alleviare la sofferenza dei «rimasti» con delicatezza e rara sensibilità. Allo stesso modo si prende cura delle sue piante, con la pazienza di chi ha appreso molto presto che ogni cosa ha il suo tempo che va rispettato e accettato.
Quando i due si incontrano, sono inesorabilmente attratti uno dall’altra, e vengono travolti da un turbinio di sentimenti ed emozioni che li disorientano. Mio, che ha sempre cercato di rifuggire l’amore considerandolo come una malattia, è turbata dal fatto che non vede in Aoi nessun colore; Aoi, giovane calmo e controllato, è ammaliato dalla sua enigmatica personalità e da quella strana sensibilità che non comprende sino in fondo, ma che si insinua in lui come una luce alla quale non riesce a sottrarsi.
Si avvicinano con lentezza e determinazione. E mentre si scoprono, mettono a nudo loro stessi e le vite dei loro famigliari, in un percorso non privo di sofferenza.
Nasce una favola incantevole in cui l’amore diventa il perno intorno al quale si snodano riflessioni profonde sulle innumerevoli sfaccettature della vita, della morte, della perdita, sull’importanza della famiglia, sull’essenza della felicità. Ma questo amore così dirompente porta con sé anche delle ombre che rischiano di farlo naufragare. Il loro incontro, infatti, non è stato casuale e quando i segreti del passato si svelano, i colori svaniscono e il mondo si tinge di grigio, perché «non appena si sa, non si è più in armonia con niente». È questo il momento della pazienza, del coraggio, dell’accettazione. «Serve perdere un po’ l’equilibrio per vedere le cose!». Da pedine del destino, Mio e Aoi si trasformano in artefici della loro vita. Nella loro diversità ricomporranno l’armonia spezzata e troveranno finalmente il loro colore, quello che li accomuna, quello in cui rifugiarsi, ritrovarsi, riconoscersi… «perché l’amore non è mai giusto, l’amore si costruisce. Proprio come sulla tela un colore».
Carla Franciosi
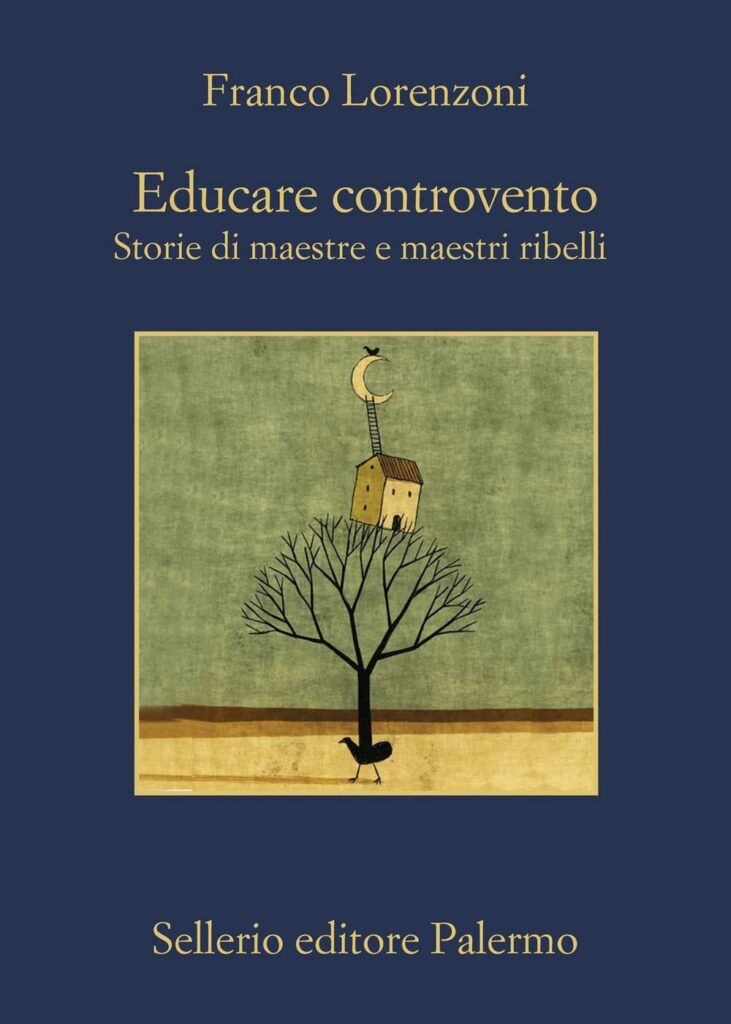 Franco Lorenzoni
Franco Lorenzoni
Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli
Sellerio Editore, Palermo, 2023, pp. 256, € 16,00
Franco Lorenzoni, maestro elementare, ricercatore e formatore, ha fatto parte del Movimento di Cooperazione Educativa ed ha fondato nel 1980 ad Amelia, in Umbria, un centro di sperimentazione, la Casa-laboratorio di Cenci. Recentemente (nel 2021) ha ricevuto due lauree honoris causa, una dall’Università Bicocca di Milano e una dall’Università di Palermo.
Come l’autore stesso dice, «Questo libro ha due andamenti che si alimentano reciprocamente». Nei capitoli dispari si parla di temi educativi, cioè di scelta, di corpo, di spazio, di tempo, di dialogo, di arte del convivere, di conversione ecologica. Nei capitoli pari si parla di persone, di maestre e maestri «che in epoche e contesti diversi hanno promosso ribellioni efficaci» ad approcci pedagogici indifferenti agli aspetti di cui sopra.
Nell’introduzione Lorenzoni presenta ciò che l’educare dovrebbe fare («liberare potenzialità, allargare gli sguardi, forgiare e mettere a punto conoscenze e strumenti in grado di moltiplicare le possibilità di scelta di ciascuno… ») e ciò che non dovrebbe mai porsi («pretendere di portare dove vogliamo noi») e afferma di aver imparato con l’esperienza «che la cooperazione, il ricercare insieme, lo scovare o creare contesti in cui condividere dubbi e domande sono alleati necessari per intraprendere la delicata opera di educare controvento, non accontentandoci di come va il mondo».
Svolge poi i diversi capitoli del testo presentando ampiamente i principi educativi in cui crede e le persone che, prima di lui, contemporaneamente a lui o insieme a lui, li hanno affermati e applicati.
Nei capitoli dedicati agli aspetti pedagogici per lui più rilevanti, Lorenzoni parte dal principio che basterebbe rispettare l’articolo 3 della costituzione per fare una buona scuola, una scuola che pone l’attenzione sul dare opportunità a tutte/i di apprendere e sul rimuovere eventuali ostacoli. Tratta poi dell’importanza del corpo nei processi di apprendimento, della necessità di coinvolgere soprattutto i più piccoli con esperienze che riguardino tutti i sensi e il movimento. E a questo si lega l’aspetto di come «abitare lo spazio», di come organizzarlo: «… il parlare in cerchio o da dietro i banchi, seduti a terra o sotto un albero in giardino» modifica l’attenzione, l’ascolto reciproco e l’espressione di pensieri. Di altrettanta rilevanza sono infine gli aspetti della cura della memoria, «a partire dalla memoria del corpo», della promozione del dialogo per «costruire cultura creando comunità», dello sviluppo dell’«arte del convivere» e della comprensione della «conversione ecologica» attraverso «uno studio della storia dell’intero mondo».
Nei capitoli dedicati alle maestre e ai maestri, da cui l’autore dice di avere imparato e/o con cui ha collaborato sia a livello di ricerca sia a livello di sperimentazione, sono presentate le figure di Piero Calamandrei, che si dedica con estrema attenzione all’«ascolto delle prime parole di suo figlio»; di Alessandra Ginzburg, che «si ribella alla segregazione in cui erano costrette a vivere bambine e bambini con disabilità»; di Emma Castelnuovo, che si oppone con forza «a un insegnamento della matematica che avvilisce le intelligenze invece di esaltare le capacità di scoperta di tutte e tutti»; di Nora Giacobini, che «si ribella all’etnocentrismo occidentale», dimostrando «vicinanza con i più fragili e i vinti»; di Mario Lodi, che si dichiara decisamente contrario «a una scuola che nega la parola a bambine e bambini»; di Don Lorenzo Milani, che denuncia il voler «confinare i poveri» nell’ignoranza; di Alexander Langer, che si leva contro «ogni accettazione passiva delle segregazioni etniche»; di Malala Yousafzai, che si fa «paladina della libertà di istruzione delle donne»; di Greta Thunberg, «che si ribella alla sottrazione di futuro di cui sono responsabili le generazioni adulte che governano il mondo».
Essenzialmente Franco Lorenzoni ritiene improrogabile modificare «le nostre pratiche educative» affinché «ogni scuola diventi luogo di creazione culturale, perché il sapere di cui abbiamo bisogno ancora non c’è e va elaborato in più contesti possibili e in primo luogo nella scuola pubblica».
Margherita Mainini
I

