Vite aperte al possibile (a cura di Carmen Leccardi)
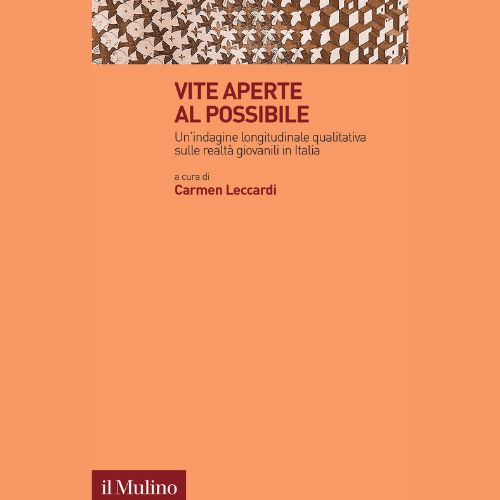 Carmen Leccardi (a cura di)
Carmen Leccardi (a cura di)
Vite aperte al possibile. Un’indagine longitudinale qualitativa sulle realtà giovanili in Italia
Il Mulino, Bologna 2025
P. 216, 19 €
Il testo appartiene a una collana, relativa alle trasformazioni della società contemporanea e in particolare di quella italiana, realizzata presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Nell’introduzione, la curatrice del testo, Carmen Leccardi, vuole anzitutto chiarire il motivo del titolo Vite aperte al possibile, partendo dallo scopo della ricerca, quello cioè di capire «in che misura e secondo quali modalità i nostri giovani siano comunque in grado di “addomesticare l’incertezza”, trasformando condizioni sfavorevoli di partenza in dinamiche di mutamento aperte al possibile».
Sono stati seguiti giovani donne e giovani uomini dai venti ai trent’anni al fine di comprendere i loro percorsi di «transizione alla vita adulta». Una transizione che vede incertezze, timori e ansie, ma che è anche aperta a una costruzione soddisfacente del presente e alla speranza di un futuro comunque possibile.
La ricerca longitudinale qualitativa, quinquennale presentata nei diversi capitoli del testo, utilizza interviste «semistrutturate e seminarrative» ripetute in tre momenti a distanza di un anno l’uno dall’altro
Nello scoprire come i giovani oggi percepiscano il loro presente e il loro futuro, non si può prescindere dalla constatazione che non si possano più utilizzare le concettualizzazioni usate per le generazioni precedenti. La realtà sociale è cambiata: precarizzazione dell’esistenza e incertezza rispetto al domani caratterizzano questo tempo e le ambizioni giovanili non possono certo più essere legate al perseguimento di un lavoro che sia stabile e che sia da subito conseguente agli studi fatti.
Questi aspetti di cambiamento spesso non sono tenuti sufficientemente in considerazione da coloro che appartengono a generazioni precedenti, che tendono a valutare le scelte di vita di figli e nipoti come poco progettuali e poco responsabili. Ma chi vive ora il passaggio all’età adulta non può fare altro che cercare adattamenti alla realtà: costruisce un’identità personale slegata dal lavoro, la cerca al di là dei mezzi di sostentamento precari e insoddisfacenti che trova. Spesso, accanto a un’attività fatta per vivere, questi giovani cercano la realizzazione di sé nel coltivare passioni personali (musica, teatro, scrittura). Passioni che non possono garantire autonomia economica, ma che attribuiscono senso alla vita privata e sociale, diventando strumento essenziale di costruzione d’identità.
Altro aspetto significativo analizzato nella ricerca è quello della prolungata permanenza dei giovani all’interno delle famiglie di origine. Nelle società europee il problema delle entrate salariali insufficienti e instabili è uno dei motivi più importanti per cui i giovani restano a vivere nella casa dei genitori più a lungo che nel passato. In Italia questo fenomeno è particolarmente accentuato: «Nel 2022, l’età media di uscita da casa dei genitori è di 30 anni, contro i 26,4 della media europea».
La lunga dipendenza dai genitori comporta relativi processi di adattamento: per giovani donne e giovani uomini diventa necessario costruire nuove negoziazioni di convivenza in famiglia. Nelle testimonianze delle intervistate e degli intervistati emergono due nodi di problematicità: «la gestione della tensione tra autonomia e dipendenza che i giovani adulti sperimentano in relazione alle loro famiglie d’origine […] e il ruolo che i genitori rivestono per la distanza generazionale con i loro figli». Ai genitori non viene più attribuita una veste di guida e il rapporto con loro è vissuto come paritario.
Al cambiamento di concezione nel privato, corrisponde nel pubblico un nuovo modo di partecipazione: scettici in genere rispetto alla tradizionale politica rappresentativa, i giovani manifestano il bisogno di «farsi promotrici e promotori di un cambiamento, all’interno di contesti collettivi di condivisione della propria visione del mondo».
Complessivamente, le nuove strategie di adattamento, negoziazione e impegno costituiscono una modalità viva e creativa della gestione della vita, ma, per molti rappresentano anche una fatica quotidiana che si traduce in «ansia da prestazione e riconoscimento» con vissuti di stanchezza, disorientamento e disagio.
«Ma [i giovani] chiedono, fortunatamente spesso, aiuto».
Margherita Mainini

