Scelti per voi (libri)
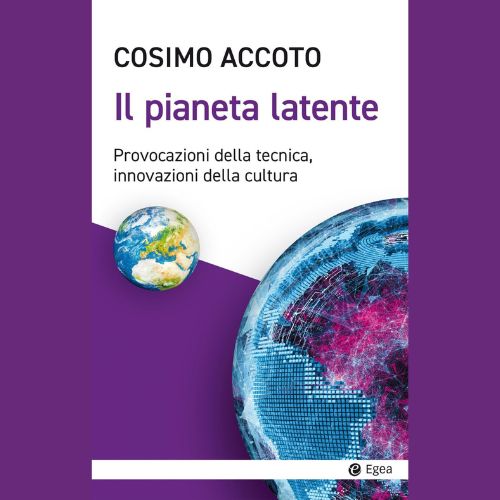 Cosimo Accoto
Cosimo Accoto
IL pianeta latente. Provocazioni della tecnica, innovazioni della cultura
Ed. Egea, Milano 2024
pp. 127, € 18
Siamo abituati ad affrontare il tema controverso dell’AI con uno sguardo tecnico/strumentale oppure etico e in questi modi lo trasferiamo anche alle giovani generazioni nelle istituzioni scolastiche. Un po’ di algoritmi in più nelle discipline scientifiche, qualche raccomandazione sulla sicurezza dei dati e sulla possibilità di contenuti immorali con uno sguardo alla previdente legislazione UE. Per contrastare il possibile riduzionismo nella didattica e voler dare invece un respiro pedagogico al tema dell’AI ho trovato molto utile il testo di Cosimo Accoto, filosofo della tecnologia, ricercatore al MIT di Boston, che approfondisce le valenze culturali della trasformazione indotta dall’AI. L’autore auspica un cambiamento del senso e dei significati secondo i quali abbiamo finora interpretato la realtà dell’AI per accedere a una raffigurazione indotta dalle nuove ingegnerie che stanno costruendo il futuro di un pianeta sull’orlo di trasformazioni che riusciamo vedere ancora solo parzialmente, latenti appunto. Quello che Accoto ci presenta è un orizzonte esplorativo sulla AI generativa che si nutre di provocazioni intellettuali sulla evoluzione tecnico-automatica di azioni finora proprie dell’umano: la comunicazione, la visione e l’azione. E il tono provocatorio della riflessione dell’autore è finalizzato a far vacillare l’elementare certezza che basti garantire il controllo dell’umano sul tecnico per governare le innovazioni prodotte dalla AI. Ma le cose stanno diversamente se analizzate con sguardo filosofico. La prima provocazione che l’autore ci lancia riguarda la trasformazione della natura della parola da umana, portatrice di significati, a ingegneristica. La macchina che scrive è infatti un sequenziatore che data una frase incompleta è capace di predire la parola successiva sulla base di probabilità statistica. La conseguenza è che mentre il linguaggio umano ha un carattere espressivo-comunicativo quello elaborato dalle piattaforme di GenAi è un assemblaggio di dati a carattere operativo. Il linguaggio sintetico è senza significato, senza una esperienza di riferimento. L’assenza di un mondo che si conosce perché se ne fa esperienza attraverso il corpo è anche quella che, secondo l’autore, si riscontra nella produzione di immagini da parte dell’AI. L’immagine viene scomposta in pixel e a ogni pixel viene assegnato un valore numerico: è la griglia quantitativa, sulla quale si possono operare una serie di variazioni, che diventa la visione della macchina. Anche l’immagine, come già il linguaggio, diventa una creazione algoritmica, generando una visione senza uno sguardo. Quello che si va definendo nella trasformazione guidata dall’AI è un mondo ingegneristico che trasforma ogni attività in operazione. Fin qui i miei orizzonti di significazione traballano ma una ulteriore sfida è quella che l’autore fronteggia in merito alla capacità agentica dell’AI. Le grandi aziende stanno già introducendo gli agenti artificiali nei processi di gestione della qualità, della manutenzione e della logistica. Sono sistemi computazionali capaci di raccogliere informazioni, interagire con ambienti e sistemi esterni e eseguire attività e compiti assegnati. Per produrre le azioni il modello cognitivo della macchina, è quello della catena di pensieri, ossia uno spacchettamento ingegneristico del compito nelle fasi di un processo contraddistinto da una catena di input e output. Gli agenti possono agire da soli, in rete di diversi agenti o in coppie/gruppi misti di agenti e lavoratori/trici umani/e. Necessità, ne consegue, di un nuovo paradigma di organizzazione del lavoro e di concepire un nuovo sfidante sistema sociotecnico. Forse pensare all’ambito del lavoro, in cui sono più esperta, mi permette di cogliere la sfida impensata che le provocazioni dell’autore vogliono lanciare: il salto di paradigma culturale richiesto da una interpretazione non più umanocentrica delle intelligenze sintetiche. I nuovi attori ingegneristici sono qui per affiancarci in una creazione di nuovi significati capace di abbracciare la nuova, impensata convivenza.
Luisella Erlicher
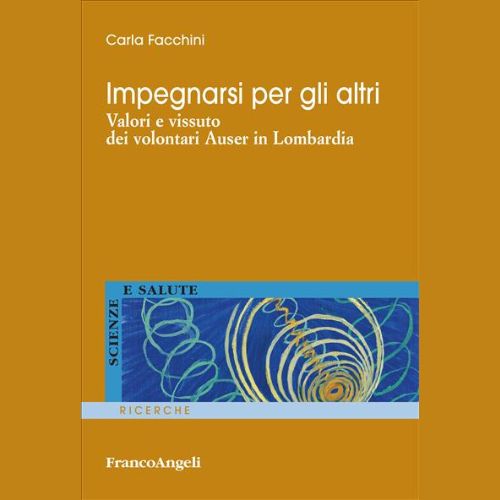 Carla Facchini
Carla Facchini
Impegnarsi per gli altri. Valori e vissuto dei volontari Auser in Lombardia
FrancoAngeli, Milano 2024
pp.166, € 24
Carla Facchini presenta e analizza i risultati di una ricerca sui volontari di Auser, Associazione per la promozione e lo sviluppo dell’autogestione dei servizi della terza età, nata nel 1989 nell’ottica di “recuperare alla vita attiva e alla vita di cittadinanza migliaia di lavoratrici e di lavoratori anziani, di pensionati e di pensionate”. Così Bruno Trentin, allora Segretario Generale della C.G.I.L., annunciava la nascita di questa associazione che, precorrendo i tempi, si poneva come finalità quella che oggi viene definita “cittadinanza attiva”.
La ricerca, «finanziata dalla Fondazione Cariplo, ha avuto come capofila l’Istituto Besta di Milano e come partner Auser Lombardia e si è articolata secondo un disegno misto che ha visto da un lato un’indagine tramite questionario strutturato e, dall’altro, un approfondimento qualitativo, tramite focus group e interviste in profondità». Essa è iniziata nel gennaio 2020 e si è conclusa nel giugno 2021, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia.
In generale, come sottolinea l’autrice, negli ultimi decenni il volontariato ha assunto una notevole rilevanza, sia perché risulta – in svariati ambiti – compensativo di un sistema di welfare che tende sempre più a ridurre i propri interventi, sia perché consente a quella fascia di popolazione che ha lasciato il mondo del lavoro, avendo raggiunto l’età della pensione, di mantenere un ruolo attivo nella comunità. Dal 1993 il tema è diventato oggetto di una rilevazione sistematica da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica. Negli ultimi anni però si assiste a una progressiva diminuzione del numero di persone che offrono il proprio impegno a titolo gratuito. L’età pensionabile si è alzata e le condizioni di salute possono risentirne, il lavoro di cura, rivolto a bambini e/o grandi anziani presenti nelle famiglie, richiede un impegno costante che può togliere tempo ed energie per altro: queste alcune delle ipotesi che vengono avanzate per spiegare il decremento.
Se questo è l’orizzonte di riferimento, seppure solo accennato per macro-tematiche rispetto al quadro puntuale e preciso che traccia l’autrice, chi sono dunque i volontari di Auser, che In Lombardia rappresentano una discreta fascia della popolazione (circa 65.000 soci di cui irca il 10% svolge attività di volontariato)? L’autrice ne analizza le caratteristiche sociali in relazione alla storia lavorativa, le reti familiari e amicali, la partecipazione sociale, le condizioni di salute, i tempi e le motivazioni del volontariato.
Due, a mio avviso, gli elementi di forza del testo. Un primo elemento è costituito dal fatto che i dati sono sempre comparati con i dati nazionali, rilevati da Istat. Ciò consente di leggere le analogie e gli scarti rispetto alla situazione nazionale e quindi il testo si presta non solo ad un’analisi del volontariato Auser, ma risulta in un certo senso emblematico di una situazione più generale del volontariato.
Il secondo elemento di forza è costituito dalla capacità dell’autrice di disegnare una sorta di quadro che rappresenta un modello di volontariato laico, composto per lo più di ex lavoratori dipendenti, capaci di impegno civile, così come era nelle intenzioni di Bruno Trentin.
Restano gli interrogativi per il futuro, che riguardano gli elementi cui si faceva cenno precedentemente, ma che attengono anche, o soprattutto, al cambiamento che il lavoro sta affrontando in questi ultimi anni, un lavoro sempre più parcellizzato, che offre minori occasioni di coesione sociale. «Questo non vuol dire, ovviamente, che [i giovani] saranno meno disponibili ad essere coinvolti nelle associazioni e nello stesso volontariato, ma può comportare che il loro impegno potrà modificarsi, assumendo forme più simili a quelle attualmente proprie dei giovani, vuoi in quanto improntate a una ridotta intermediazione organizzativa da parte delle associazioni, vuoi in quanto basate su programmi e obiettivi specifici ma “a termine”, vuoi infine in quanto connotate da affiliazioni multiple, ma meno forti».
Claudia Alemani
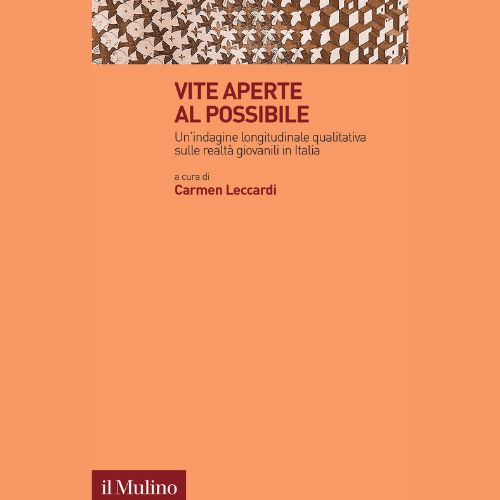 Carmen Leccardi (a cura di)
Carmen Leccardi (a cura di)
Vite aperte al possibile. Un’indagine longitudinale qualitativa sulle realtà giovanili in Italia
Il Mulino, Bologna 2025
pp. 216, 19 €
Il testo appartiene a una collana, relativa alle trasformazioni della società contemporanea e in particolare di quella italiana, realizzata presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Nell’introduzione, la curatrice del testo, Carmen Leccardi, vuole anzitutto chiarire il motivo del titolo Vite aperte al possibile, partendo dallo scopo della ricerca, quello cioè di capire «in che misura e secondo quali modalità i nostri giovani siano comunque in grado di “addomesticare l’incertezza”, trasformando condizioni sfavorevoli di partenza in dinamiche di mutamento aperte al possibile».
Sono stati seguiti giovani donne e giovani uomini dai venti ai trent’anni al fine di comprendere i loro percorsi di «transizione alla vita adulta». Una transizione che vede incertezze, timori e ansie, ma che è anche aperta a una costruzione soddisfacente del presente e alla speranza di un futuro comunque possibile.
La ricerca longitudinale qualitativa, quinquennale presentata nei diversi capitoli del testo, utilizza interviste «semistrutturate e seminarrative» ripetute in tre momenti a distanza di un anno l’uno dall’altro
Nello scoprire come i giovani oggi percepiscano il loro presente e il loro futuro, non si può prescindere dalla constatazione che non si possano più utilizzare le concettualizzazioni usate per le generazioni precedenti. La realtà sociale è cambiata: precarizzazione dell’esistenza e incertezza rispetto al domani caratterizzano questo tempo e le ambizioni giovanili non possono certo più essere legate al perseguimento di un lavoro che sia stabile e che sia da subito conseguente agli studi fatti.
Questi aspetti di cambiamento spesso non sono tenuti sufficientemente in considerazione da coloro che appartengono a generazioni precedenti, che tendono a valutare le scelte di vita di figli e nipoti come poco progettuali e poco responsabili. Ma chi vive ora il passaggio all’età adulta non può fare altro che cercare adattamenti alla realtà: costruisce un’identità personale slegata dal lavoro, la cerca al di là dei mezzi di sostentamento precari e insoddisfacenti che trova. Spesso, accanto a un’attività fatta per vivere, questi giovani cercano la realizzazione di sé nel coltivare passioni personali (musica, teatro, scrittura). Passioni che non possono garantire autonomia economica, ma che attribuiscono senso alla vita privata e sociale, diventando strumento essenziale di costruzione d’identità.
Altro aspetto significativo analizzato nella ricerca è quello della prolungata permanenza dei giovani all’interno delle famiglie di origine. Nelle società europee il problema delle entrate salariali insufficienti e instabili è uno dei motivi più importanti per cui i giovani restano a vivere nella casa dei genitori più a lungo che nel passato. In Italia questo fenomeno è particolarmente accentuato: «Nel 2022, l’età media di uscita da casa dei genitori è di 30 anni, contro i 26,4 della media europea».
La lunga dipendenza dai genitori comporta relativi processi di adattamento: per giovani donne e giovani uomini diventa necessario costruire nuove negoziazioni di convivenza in famiglia. Nelle testimonianze delle intervistate e degli intervistati emergono due nodi di problematicità: «la gestione della tensione tra autonomia e dipendenza che i giovani adulti sperimentano in relazione alle loro famiglie d’origine […] e il ruolo che i genitori rivestono per la distanza generazionale con i loro figli». Ai genitori non viene più attribuita una veste di guida e il rapporto con loro è vissuto come paritario.
Al cambiamento di concezione nel privato, corrisponde nel pubblico un nuovo modo di partecipazione: scettici in genere rispetto alla tradizionale politica rappresentativa, i giovani manifestano il bisogno di «farsi promotrici e promotori di un cambiamento, all’interno di contesti collettivi di condivisione della propria visione del mondo».
Complessivamente, le nuove strategie di adattamento, negoziazione e impegno costituiscono una modalità viva e creativa della gestione della vita, ma, per molti rappresentano anche una fatica quotidiana che si traduce in «ansia da prestazione e riconoscimento» con vissuti di stanchezza, disorientamento e disagio.
«Ma [i giovani] chiedono, fortunatamente spesso, aiuto».
Margherita Mainini
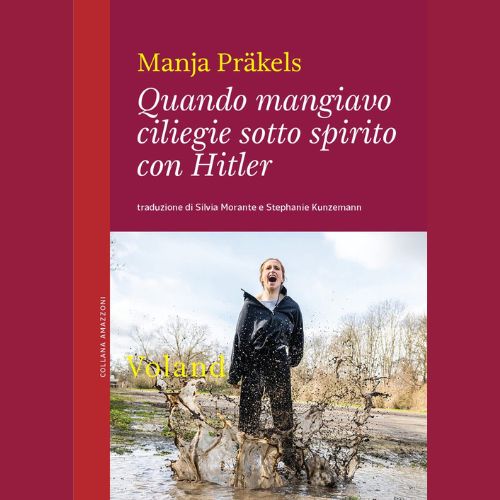 Manja Pr?kels
Manja Pr?kels
Quando mangiavo ciliegie sotto spirito con Hitler
Voland, Roma 2022
pp. 248, € 18,00
Quando, il 9 novembre 1989, il mondo assisteva incredulo alla caduta del muro di Berlino tutti abbiamo creduto che l’apertura di quell’ignominioso confine fosse, per gli abitanti della DDR, l’inizio di un futuro di libertà e benessere, dopo quasi trent’anni di esclusione e isolamento.
Ma non tutto fu così semplice e immediato. In questo suo romanzo d’esordio, in parte autobiografico, Manja Pr?kels ci racconta la dura realtà di quegli anni, catapultandoci, con una prosa potente ed evocativa venata di ironia e disincanto, nel cuore di un paese che oggi non c’è più e che vive solo nei ricordi di chi ne faceva parte, come lei.
I primi capitoli si aprono su quel mondo ancora chiuso, in una cittadina della DDR sul fiume Havel non lontano da Berlino. Nonostante le palazzine grigie ed anonime in stile sovietico, Mimì, la protagonista, alter ego dell’autrice, ci trasmette, attraverso i suoi occhi di bimba, l’immagine di un mondo povero, semplice, ma sereno, fondato su una consolidata solidarietà collettiva. Mimì vive con la madre, un’insegnante, convinta comunista, il padre, spesso malato e ubriaco, il fratellino Aldolar e l’amata nonna Frieda, sua confidente ed amica. Tra i suoi compagni di giochi c’è Oliver, figlio dei vicini, un ragazzo un po’ più grande di lei, schivo e di poche parole, con il quale si apparta, durante le tavolate degli adulti per mangiare di nascosto le ciliegie sotto spirito. Sono gli anni della scuola, dei campi estivi in Russia o in Polonia, delle parate celebrative, dello sport, della disciplina, gli anni delle vittorie alle Olimpiadi, che riempiono i cuori di orgoglio patriottico. Mimì si sente fieramente parte di quel mondo che la fa sentire protetta e al sicuro.
Crescendo però, al suo sguardo attento e curioso non sfuggono i primi segni di un disagio strisciante, un malcontento represso che cova negli animi di giovani e adulti e induce qualcuno a “scappare dall’altra parte”.
Mimì fatica a capire… «avrei capito solo anni dopo che facevamo tutti parte di un mondo che stava morendo» e quando ciò accade Mimì ha quindici anni. Non più bambina, ma non ancora adulta, vede crollare intorno a sé il suo mondo e, con esso, un intero sistema di valori.
La riunificazione porta con sé cambiamenti radicali in tutte le strutture sociali e nella riorganizzazione economica molti restano disoccupati, altri devono riqualificarsi per adeguarsi ai nuovi standard e, mentre i cartelloni pubblicitari invadono le città, i poveri vengono spinti ai margini, i giovani, chiusi i centri di aggregazione, si trovano per strada.
All’iniziale euforia subentra la disillusione, il disorientamento, il senso di solitudine e di impotenza di una nazione che si sente privata della propria identità e fatica ad adattarsi al cambiamento.
In questo clima, c’è chi guarda al passato per riconoscersi in un nuovo ideale. Compaiono le teste rasate, gli anfibi, i giubbotti mimetici, le spranghe. Sono i “gorilla”, squadre di giovani neonazisti, facinorosi e violenti, il cui capo è proprio Oliver, nome di battaglia “Hitler”. Sono loro i predatori che, seminando terrore e devastazione, spacciano droga, controllano i locali, dettano le regole, e danno la caccia a punk, africani, senza tetto e alle “zecche comuniste” tra cui anche Mimì e i suoi amici. Costretta a fuggire e a nascondersi Mimì si muove tra spazi fatiscenti e ostili alla ricerca costante di un proprio posto in una realtà devastata dalla paura e dall’incertezza, cercando di mantenere i legami con la famiglia e gli amici in un rapporto di solidarietà e reciproco aiuto.
L’amicizia diventa il perno per la ricerca della salvezza e la ricostruzione di un’identità perduta, attraverso la quale alla fine Mimì riuscirà a riconciliarsi con l’idea che “Hitler” fosse comunque il ragazzo che le salvò la vita.
Manja Pr?kels riesce ad appassionarci e commuoverci restituendoci il quadro vivo e palpitante di un momento storico che forse in Occidente non è stato compreso nella sua profonda complessità e ci fornisce uno strumento prezioso per riflettere sugli eventi odierni in un’Europa in cui gli spettri del passato sembrano riaffacciarsi con preoccupante prepotenza.
Carla Franciosi

